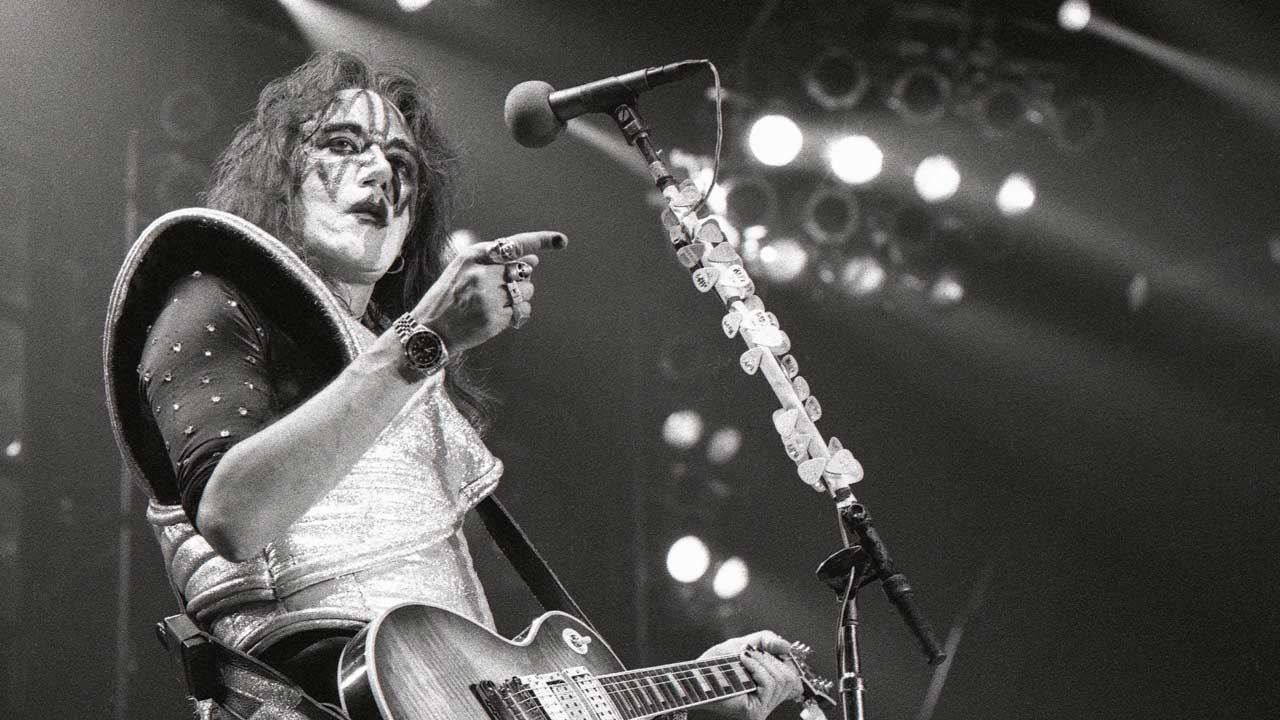C’è fermento nella moda

C’è fermento – anzi, fermentazione – nel mondo del tessile e della moda. Questa l’elettrizzante conclusione emersa dalla visita alla Biofab Fair di Londra
La Biofab Fair di Londra è un’esposizione di materiali innovativi e, soprattutto, di idee che nascono dall’attenta osservazione di ciò che la natura può offrire.
La chiave di volta? Processi fermentativi e tecnologie all’avanguardia che consentono di produrre pigmenti, tinture, cellulosa batterica e proteine in grado di sostituire prodotti tradizionali ottenuti da risorse non rinnovabili o con processi poco sostenibili.
Di seguito, una piccola selezione commentata delle realtà più interessanti osservate durante una giornata passata tra gli stand, in compagnia di Alessandra Gallo, consulente per la moda a basso impatto, founder dello studio di consulenza Fashionable Green, docente Ied, lecturer Poli.Design e founder del collettivo Moda Consapevole di Roma.
Gallo, a questo proposito, afferma che “le fiere come Bio-fabricate e Future Fabric sono la concreta espressione dell’impegno di molte aziende a ridurre l’impatto ambientale partendo dall’innovazione.
Un impegno globale data la presenza di aziende da molte parti del mondo: Europa, Giappone, Australia, Stati Uniti e India. È ormai noto come la fase di design sia responsabile dell’80% dell’impatto del prodotto e la bioingegneria sta dimostrando di poter fornire soluzioni efficaci per rendere un prodotto circolare (riciclabile) o biodegradabile.
C’è ancora molto lavoro da fare su estetica, tessitura, consistenza dei materiali e sulle loro finiture, ancora troppo legate a polimeri di origine fossile. Ma non c’è dubbio che questo settore stia evolvendo velocemente“.
Tinture e pigmenti naturali
Il processo di tintura attuale coinvolge trattamenti e pigmenti di origine artificiale particolarmente impattanti sull’ambiente.
Inoltre, l’efficacia del trattamento deve considerare la complementarità delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale e del pigmento. Quante volte ci è capitato di trovare capi con colori danneggiati dopo il bucato?
Questo è il risultato di un processo di tintura di scarsa qualità. Passare dai materiali tradizionali ai materiali innovativi richiede quindi innovazione e ricerca di pigmenti adeguati, se ci si vuole spostare verso la sostenibilità e, possibilmente, anche un minore impatto ambientale.
L’azienda britannica Colorifix, con un impianto produttivo anche in Portogallo, è un esempio interessante che porta una proposta sia di pigmenti naturali che di processo di tintura sostenibili.
I pigmenti vengono ottenuti attraverso la fermentazione microbica e il brodo di coltura stesso viene utilizzato come bagno di fissazione del colore. Normalmente le due fasi sono condotte separatamente, con conseguente aumento dei costi e di impatto ambientale.
L’innovazione porta a una riduzione di reagenti chimici (oltre l’80%), di emissioni di anidride carbonica (30%), consumo di acqua (77%). L’azienda ha saputo attrarre i finanziamenti necessari per la transizione da piccole realtà industriali a una capacità commerciale su grandi volumi, sostenendo la transizione ecologica.
Economia circolare: dalla birra alla simil-pelle
Tanta la birra e il whisky che si beve nel mondo: perché quindi non immaginare di dare una seconda vita agli scarti di produzione? L’azienda londinese Arda Biomaterials recupera i grani spenti della produzione di birra e whiskey, trasformandoli in New Grain, un materiale simile al cuoio.
Un aspetto particolarmente interessante da un punto di vista della sostenibilità è dato dalla eliminazione del processo di tintura che è ancora altrimenti particolarmente impattante da un punto di vista ambientale: la simil-pelle possiede già naturalmente sfumature di colori che variano dal giallo paglierino al nero a seconda del grado di tostatura della materia prima di scarto.
Il problema si pone se desideriamo una borsa di simil pelle con una colorazione differente.
Funghi e cellulosa batterica
I polisaccaridi, quali la cellulosa, sono utilizzati fin dall’antichità come fibre tessili (pensiamo al cotone). Tuttavia le coltivazioni di cotone hanno un impatto ambientale rilevante, non solo in termini di utilizzo di terreno agricolo, ma di consumo di acqua.
La cellulosa di origine batterica e il micelio dei funghi stanno emergendo come fibre a minor impatto. Il micelio dei funghi è composto principalmente da chitina (un polisaccaride presente anche nell’esoscheletro degli insetti e dei crostacei) e da cellulosa.
Una realtà tutta Italiana, Sqim, possiede una tecnologia di fermentazione per produrre Ephea, materiale alternativo destinato alla moda di lusso, derivante dal micelio dei funghi che si pone come alternativa alla pelle animale.
La cellulosa, il polimero del glucosio con funzione strutturale nelle piante, viene sintetizzata anche da alcuni batteri, accumulandosi come pellicola di nanofibre all’interfaccia liquido-aria.
In Messico nasce così Celium – il cui nome unisce Cel da cellulosa e il suffisso latino -ium degli elementi chimici. Per nutrire i batteri e stimolare la produzione di cellulosa, l’azienda utilizza gli scarti industriali della lavorazione della frutta, creando un ciclo produttivo altamente efficiente.
Una piccola perla (sostenibile)
Dall’India, arriva l’idea di Cellsense. trasformare, con un’innovativa tecnologia di stampa 3D, una miscela di alghe e cellulosa in perle colorate con pigmenti di origine naturale. Un vero e proprio gioiello di sostenibilità!

Queste realtà dimostrano come la biofabbricazione stia non solo offrendo alternative, ma stia anche riscrivendo le regole dell’industria della moda, rendendo la catena di valore della moda e del tessile più etica e circolare. Quale di queste innovazioni avrà l’impatto maggiore sul mercato nel prossimo futuro?
La sfida è riuscire a portare su larga scala i processi e sul mercato i prodotti a un prezzo accessibile, ma al contempo comunicare adeguatamente al consumatore la sostenibilità dei prodotti, affinché possa fare una scelta consapevole nel rispetto ambientale, anche se più limitata da un punto di vista estetico.
Cos’è la fermentazione microbica industriale?
La fermentazione industriale è un processo biotecnologico cruciale e controllato, su larga scala, con il quale microrganismi selezionati, come batteri, lieviti o funghi, convertono materie prime (rinnovabili o scarti industriali) in una vasta gamma di prodotti di valore.
Questi includono alimenti, bevande, biocarburanti, fibre, bioplastiche, prodotti farmaceutici e intermedi chimici ad alto valore aggiunto. Oggi, l’integrazione di discipline come la microbiologia, la chimica e l’ingegneria genetica permette di ottimizzare i ceppi microbici per ottenere rese elevate e prodotti specifici per le applicazioni desiderate.
Nonostante la sua attuale sofisticazione, la fermentazione è un processo che affonda le radici nelle origini dell’umanità. Sin dall’antichità, gli esseri umani hanno sfruttato i microrganismi per la produzione di alimenti e bevande, come yogurt, formaggi, vino, birra e prodotti lievitati.
Ha radici storiche anche l’uso della fermentazione per la produzione dei pigmenti per la tintura dei tessuti. I vichinghi, per esempio, utilizzavano la pianta del guado (Isatis tinctoria) per ottenere un colorante blu che oggi dà il colore al denim.
Questo processo richiedeva l’impiego di urina fermentata, che forniva le condizioni e i nutrienti necessari affinché i batteri potessero produrre il pigmento in una forma solubile (indigotina) da poter fissare sulle fibre tessili.
In sostanza, quella che era una pratica empirica si è trasformata, grazie alla scienza moderna, in una tecnologia di precisione fondamentale per l’economia circolare e la sostenibilità di processi e prodotti.
» Leggi tutti gli articoli di Il lato verde della chimica (#chimica-verde)
 Laura Cipolla: curiosa su tutto ciò che coinvolge la trasformazione della materia, dai sistemi viventi alle applicazioni della chimica, in particolare quelle legate alle biotecnologie. Per lei, la chimica è la vita, è il nostro Pianeta | Linkedin
Laura Cipolla: curiosa su tutto ciò che coinvolge la trasformazione della materia, dai sistemi viventi alle applicazioni della chimica, in particolare quelle legate alle biotecnologie. Per lei, la chimica è la vita, è il nostro Pianeta | LinkedinL'articolo C’è fermento nella moda è stato pubblicato su GreenPlanner Magazine.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


































































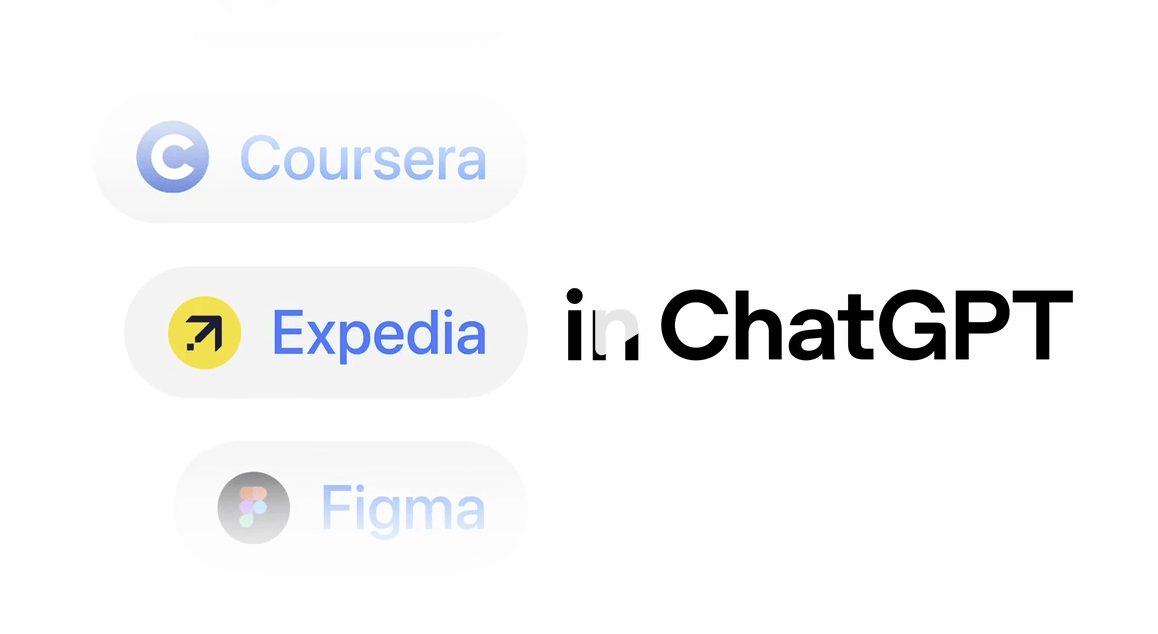


















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184280.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/10/wp_drafter_184278.jpg)




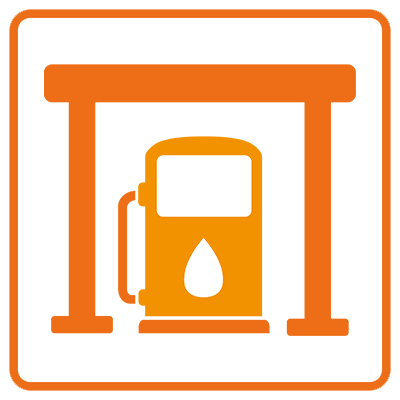












































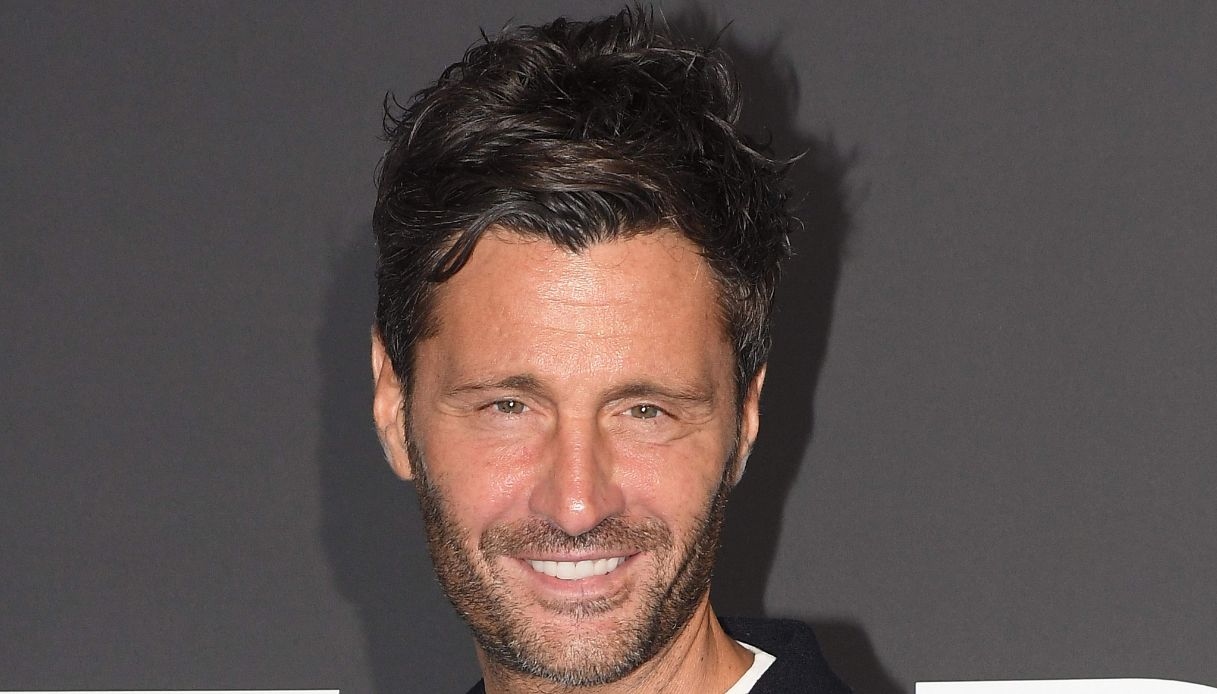





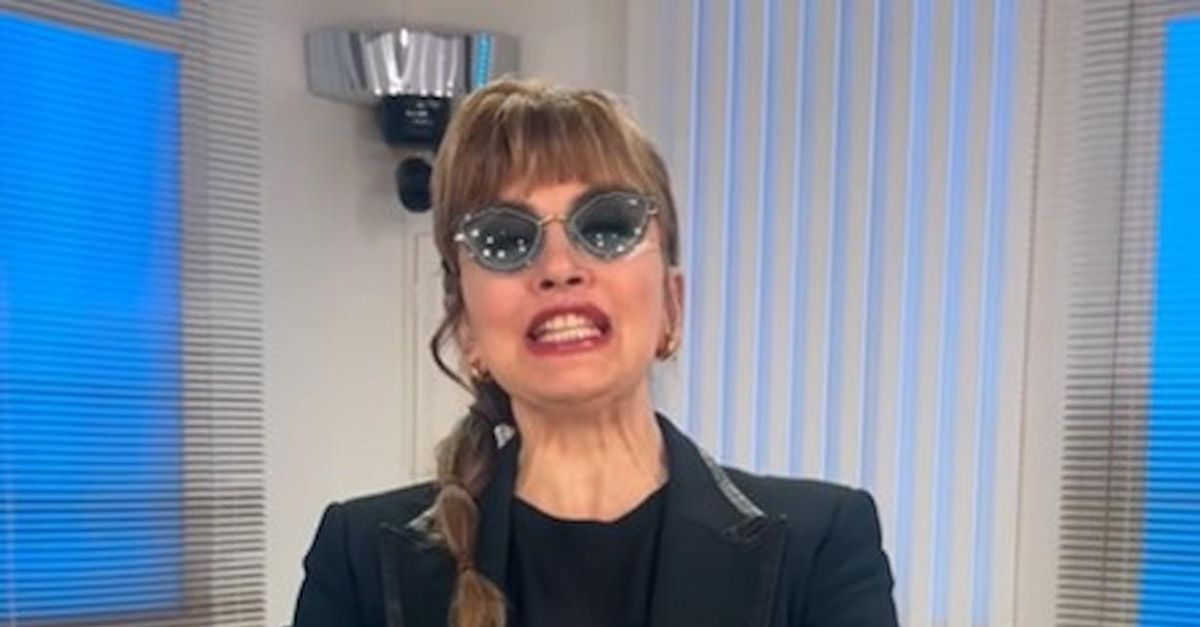


























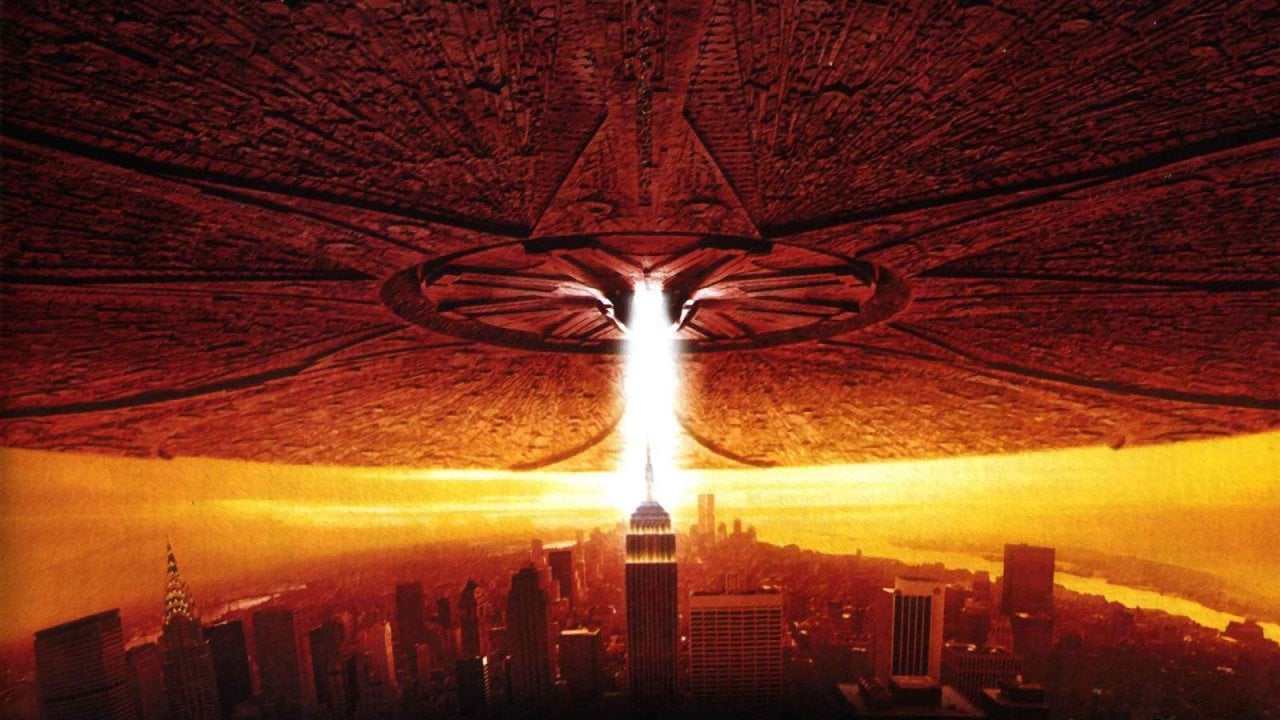
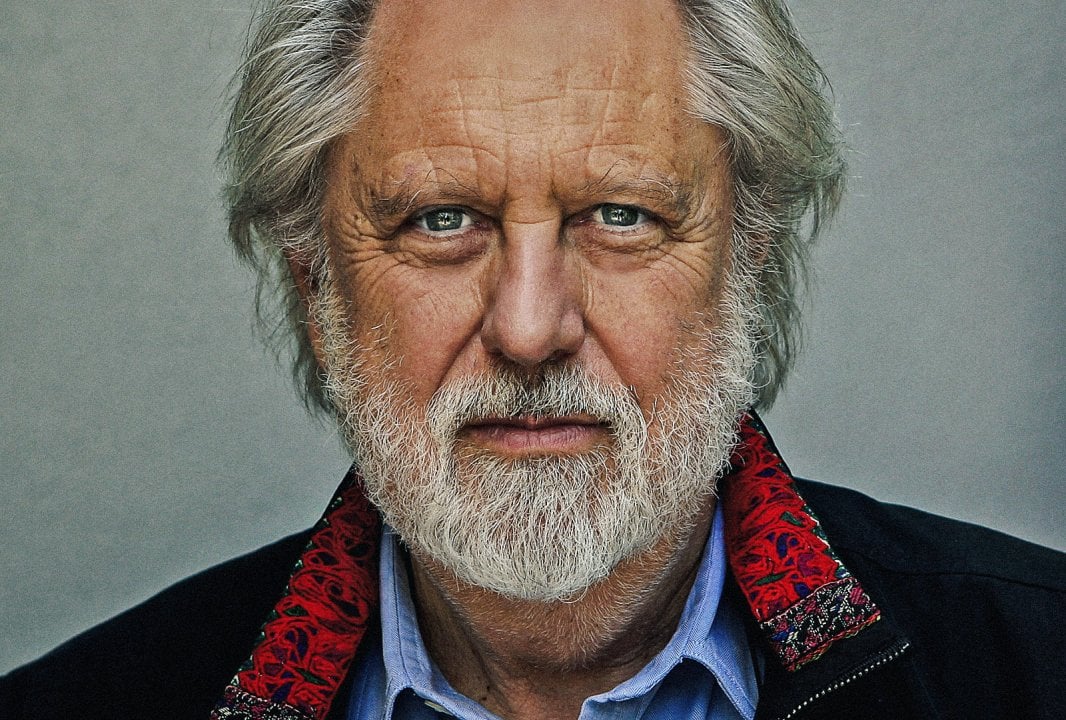





.png)




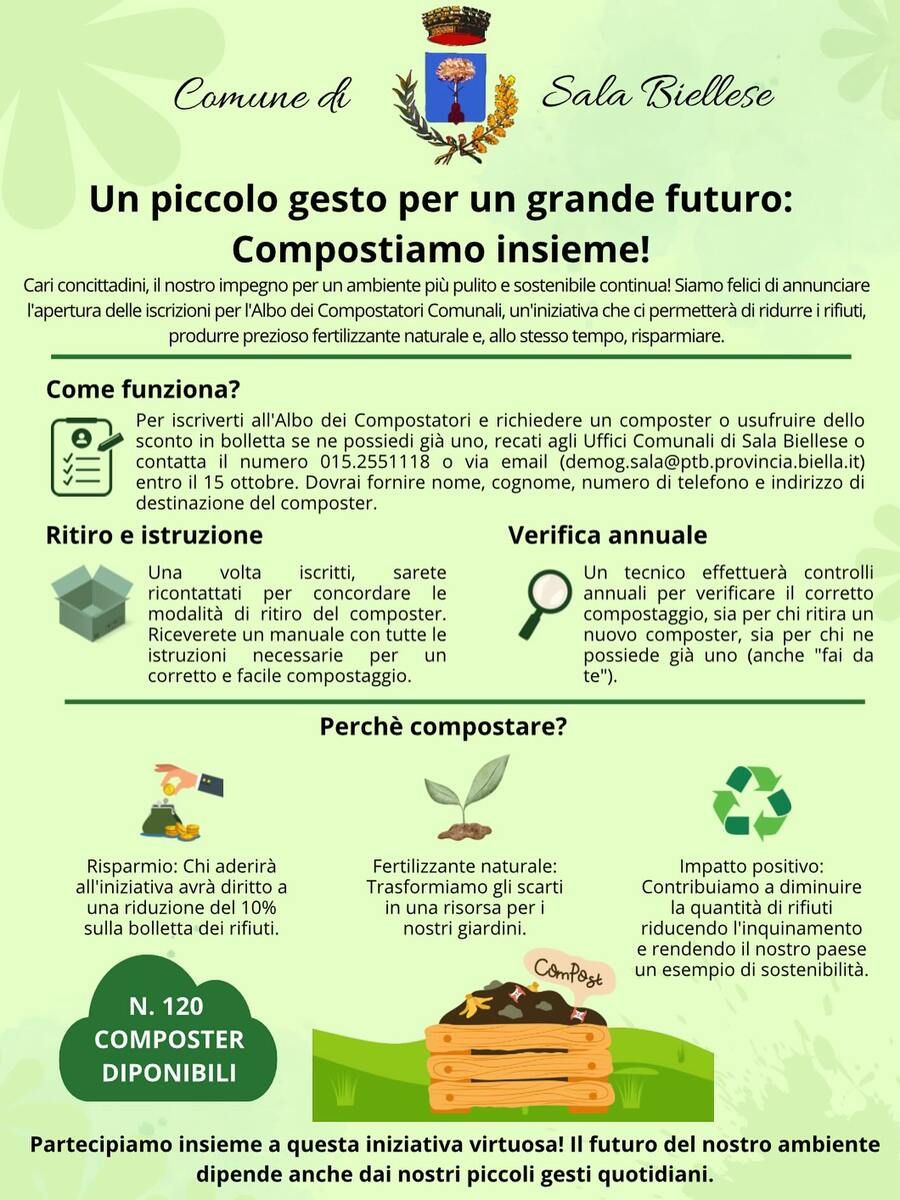





-1760794656640.jpeg--torino_intitola_tre_nuove_vie_rendendo_omaggio_a_tre_donne_di_eccezionale_valore.jpeg?1760794656733#)




-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)