Il destino di un intellettuale dato in pasto a un Paese incapace di fare giustizia


Nelle prime ore della mattina del 25 aprile del 1946, a un anno esatto dalla Liberazione, la moglie e i figli dello scienziato ebreo Tullio Terni, allarmati dall’insolito ritardo per la colazione di un uomo maniacalmente legato al culto della puntualità, si precipitarono nella sua stanza e trovarono il suo corpo oramai senza vita, avvolto in un plaid scuro. Terni aveva appena ingerito una fiala di cianuro, la stessa che qualche anno prima si era procurato, per non finire nelle grinfie delle SS, da uno dei laboratori scientifici di cui era stato prestigioso collaboratore. “Era stato”, e non “era” più, perché Terni, scienziato di fama, docente universitario, membro dell’Accademia dei Lincei, era stato cacciato dall’università e messo al bando dalla vita civile a causa delle leggi razziali del ’38.
L’antisemitismo di Stato, la pagina più orrenda e vergognosa del fascismo, lo aveva espulso, emarginato, ridotto al silenzio, costretto alle pratiche più umilianti per mitigare la condizione di paria in cui lui, la moglie Mary e i figli “Cucco” e “Lullina”, erano stati segregati. Si era procurato il cianuro perché non voleva che la sua vita e quella della sua famiglia venisse stroncata per mano dei nazisti: voleva decidere lui quando e come morire. Preferiva morire con dignità, non dargliela vinta, anticipare i plotoni di esecuzione che stavano insanguinando Firenze dopo l’8 settembre del ’43. Ma quella fiala di cianuro fu usata da Terni per aver subito un’altra e inattesa umiliazione: il verdetto di epurazione dall’Accademia dei Lincei pronunciato da un tribunale che lo aveva messo al bando una seconda volta come “vile” e “fascista”. Un professore ebreo, cacciato come ebreo durante il fascismo, accusato di complicità con il fascismo da un tribunale antifascista. Terni non resse alla vergogna, alla disperazione, all’ingiustizia patita. E si tolse la vita il 25 aprile, primo anniversario della Liberazione.
Ma perché? Come è stato possibile che un professore ebreo discriminato potesse essere squalificato da una commissione epuratrice come complice di un regime che lo aveva messo così brutalmente ai margini? Come è stato possibile che una fiala di cianuro che pure doveva impedire la cattura da parte delle SS fu invece usata a causa della vergogna inflitta da una giuria antifascista, cioè esattamente per il contrario? E quale intimazione al silenzio ha cancellato dalla memoria collettiva il nome e la paradossale vicenda personale di Tullio Terni, scienziato ebreo perseguitato due volte: dal razzismo fascista prima e dall’ingiustizia antifascista dopo?
Tullio Terni è uno dei personaggi più menzionati nel Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, e comunque forse l’unico tra i personaggi del romanzo a essere lontano da ogni tentazione cospirativa antifascista. Collaboratore del padre di Natalia, lo scienziato Giuseppe Levi, aveva messo in comune con lui importanti studi di istologia, anatomia, embriologia, biologia. Frequentava assiduamente casa Levi insieme alla moglie Mary e ai due figli, inappuntabilmente vestiti di bianco come la loro bambinaia Assunta, anche lei, di rigore, “grembiule bianco e calze bianche di filo di Scozia”.
Terni, racconta Natalia Ginzburg, era “un uomo colto, aveva letto tutti i romanzi moderni e fu il primo a portare in casa nostra la Recherche du temps perdu”, cercando di rassomigliare, con quella “caramella” che portava costantemente all’occhio, alla figura di Swann. Aveva atteggiamenti da esperto dandy, i capelli impomatati, “con i suoi sussurri estatici cacciava il naso nelle tende logore della nostra stanza da pranzo, chiedendo se erano nuove”. Terni “aveva portato in casa il gusto della malinconia, degli atteggiamenti malinconici, così come aveva portato la Nouvelle Revue Française e le riproduzioni di Felice Casorati”. Quando Ettore Petrolini arrivava a Torino, lui comprava per tutti i biglietti del teatro. Anzi no, quasi per tutti. Non per il burbero Giuseppe Levi, tutto preso dai suoi microscopi e dalle sue provette, che liquidava il teatro, la letteratura, la musica, lo svago culturale come perdite di tempo e perciò, quando sentiva il suo collaboratore parlare di Proust, commentava: questo Proust “doveva essere un tanghero”. Considerava Terni un eccellente scienziato (“mio padre ne aveva molta stima”) ma un “poseur”, un frivolo, uno che si metteva in posa. Nel lessico famigliare di casa Levi tutti capivano i sottintesi del termine “poseur”.
“Poseur” era una delle tante invettive e imprecazioni con cui Giuseppe Levi, uomo spigoloso e ruvido – doccia fredda all’alba, anche negli inverni più rigidi; estenuanti escursioni sulle vette come unico passatempo lecito – coloriva il suo linguaggio iracondo: “sgarabazzi”, “sempio”, “sempiezzi”, “sbrodeghezzi”, “malignazzo”, “potacci”, “malagrazie” e così via. Terni era un “poseur” perché leggeva libri strani e vestiva con eleganza. Non faccia lo “sempio”, collega Terni, “deve finire il suo lavoro sulla patologia dei tessuti!”. Caratterialmente e fisicamente Levi e Terni erano l’opposto. Lo ha ricordato Rita Levi-Montalcini, allieva di Giuseppe Levi, in un libro del 1987, Elogio dell’imperfezione, il primo a parlare, meritoriamente, del suicidio di Tullio Terni. Per essere precisi, il primo a parlare di Terni tout court: quarantuno anni dopo la sua morte.
“Levi era alto, di costituzione robusta, rinvigorita dalla sua passione per la montagna”: “i folti capelli rossi che gli erano valsi tra gli amici l’affettuoso nomignolo di LeviPom (diminutivo di pomodoro), il modo di incedere con la testa un po’ china, la completa indifferenza per il suo vestiario, facevano pensare a un russo di professione incerta tra il mugik e il filosofo”. Invece Terni aveva un “viso bello e regolare dai tratti tipicamente semiti. Vestiva con ricercatezza, il monocolo incastrato sotto l’arcata sopraccigliare destra accentuava l’eleganza ottocentesca della sua figura sottile”. La sua era “una conversazione brillante, piena di brio”.

L'articolo Il destino di un intellettuale dato in pasto a un Paese incapace di fare giustizia proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















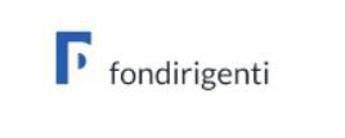




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































