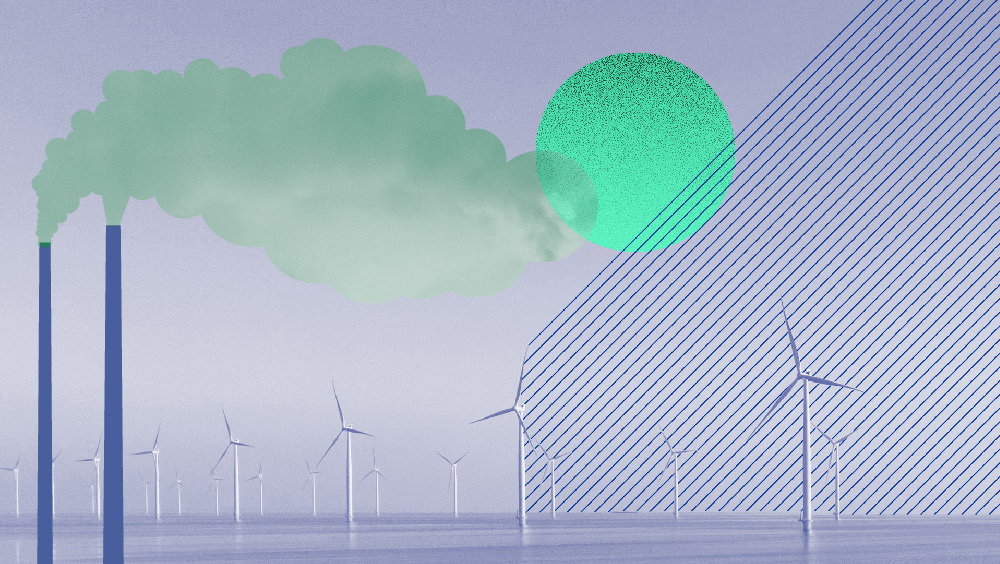Rifiuti e legalità: la stretta del decreto “Terra dei fuochi” dopo la sentenza della Corte Ue


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge 116, ribattezzato “Terra dei fuochi”. Il provvedimento nasce dall’urgenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del gennaio scorso, che ha censurato l’Italia per l’insufficienza delle misure a tutela della popolazione esposta ai roghi tossici e agli sversamenti illegali, e dalla necessità di recepire in anticipo i contenuti della nuova direttiva europea 2024/1203 in materia di tutela penale dell’ambiente.
Il decreto agisce su più fronti. Sul piano penale, viene limitato l’uso dell’istituto della “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.), sottraendo a tale beneficio gran parte dei reati ambientali. Al tempo stesso, i delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo (art. 452-sexies c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) vengono aggravati: se la condotta genera pericolo per la vita delle persone o per l’integrità dell’ambiente, la pena è aumentata fino alla metà.
Il cuore della riforma riguarda però la gestione dei rifiuti. L’articolo 255 del Codice dell’ambiente è stato riscritto e punisce con ammende più elevate l’abbandono di rifiuti non pericolosi, prevedendo anche pene detentive quando la condotta è posta in essere da imprese o enti. Due nuove disposizioni completano il quadro: l’articolo 255-bis, che incrimina l’abbandono di rifiuti non pericolosi in situazioni idonee a creare concreto pericolo per la salute e l’ambiente, e l’articolo 255-ter, che punisce l’abbandono di rifiuti pericolosi con pene fino a sei anni e mezzo nei casi aggravati. Si crea così una progressione normativa che calibra le sanzioni in funzione della natura del rifiuto e della gravità delle conseguenze.
Non meno rilevanti sono le modifiche agli articoli 256 e 256-bis sullo smaltimento non autorizzato e sulla combustione illecita, che vedono un rafforzamento delle pene, e all’articolo 259, ora rubricato “spedizione illegale di rifiuti”, affiancato dai nuovi articoli 259-bis e 259-ter per disciplinare ulteriori ipotesi di traffico transnazionale. Rafforzata anche la disciplina della tracciabilità: la violazione degli obblighi di registrazione e formulario (art. 258) comporta ora sanzioni più pesanti.
Sul piano processuale e amministrativo, il legislatore introduce strumenti innovativi e di forte impatto: l’arresto in flagranza differita per i reati più gravi, l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza come fonte probatoria per documentare le violazioni, e misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e la cancellazione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese recidive. Proprio quest’ultimo è oggetto di un significativo potenziamento, con la previsione di sanzioni ulteriori e severe, tra cui la cancellazione con divieto di reiscrizione per due anni.
Il d.l. 116/2025 rappresenta dunque un intervento organico che rafforza la repressione, disegna nuove fattispecie e dota le autorità di indagine di strumenti più penetranti. Non mancano, tuttavia, profili problematici: la sovrapposizione tra le nuove incriminazioni e figure già presenti nell’ordinamento rischia di generare incertezze applicative e conflitti interpretativi; l’ampio ricorso a misure interdittive e accessorie, se non calibrato, potrebbe determinare effetti sproporzionati e un contenzioso crescente; l’uso estensivo delle immagini di videosorveglianza apre interrogativi sul bilanciamento tra esigenze repressive e tutela dei diritti fondamentali; la stessa cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali, se applicata rigidamente, rischia di tradursi in una sanzione di fatto esiziale per imprese che operano in settori già complessi.
In definitiva, la scelta politica è chiara: interrompere la stagione dell’indulgenza verso i crimini ambientali e rispondere con rigore a un fenomeno che da decenni mina salute pubblica, legalità e fiducia dei cittadini. Ma la severità repressiva, se non accompagnata da chiarezza normativa e da un disegno sistematico di prevenzione, rischia di produrre disorientamento negli operatori e di spostare il peso della lotta all’illegalità su strumenti più punitivi che realmente risolutivi.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0



















































































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/paypal-promuove-pagamenti-stablecoin.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/07/hype-logo-1.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/approfitta-2-percento-interesse-trade-republic-nessun-vincolo-solo-vantaggi.jpg)
























































































.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)