Baricco e la chiusura della mente italiana davanti alla guerra


Non sono un fan di Alessandro Baricco, ma non ho mai trovato convincenti nemmeno gli argomenti dei suoi detrattori più accaniti. Rimproverargli di essere narcisista e lezioso, accusarlo di star sempre lì a specchiarsi nelle sue frasi a effetto e nelle sue trovate, fino al punto da perdere di vista il senso stesso di quel che scrive, mi sono sempre sembrate critiche ingenerose e anche un po’ sciocche, trattandosi di letteratura. Un campo in cui, al limite, la capacità di non dire nulla e al tempo stesso di dirlo benissimo si potrebbe persino considerare l’obiettivo massimo cui aspirare, e tutto il resto (il significato, il messaggio, il contenuto) un carico inutile di cui sbarazzarsi.
Quando però dalla letteratura si passa alla più stretta attualità, spaziando da Gaza all’Ucraina, come fa Baricco nel suo lungo articolo pubblicato ieri su Substack, mettersi in posa e dire frasi vuote di senso al solo scopo di strappare l’applauso del pubblico, perché fatte apposta per piacergli, a un certo pubblico molto esattamente individuato e coccolato, non è più uso di mondo e capacità di fare il proprio mestiere, ma una cosa del tutto diversa. È un problema che non riguarda solo Baricco, a dire la verità, ma tanti scrittori e intellettuali italiani, a cominciare da quello che nei giorni in cui i russi invadevano l’Ucraina, uccidendo e torturando uomini, donne e bambini, compariva in video con le lacrime agli occhi per denunciare la gravità di quanto stava accadendo, e cioè che qualche zelante dirigente dell’università gli aveva sospeso un seminario su Dostoevskij. Ma il discorso si farebbe troppo lungo. Restiamo dunque a Baricco.
Finché parla di Gaza, per quanto lo faccia in modo così lezioso da risultare quasi di cattivo gusto, come un selfie scattato dal luogo di una tragedia con lo sguardo severo e le labbra a culo di gallina, poco male. Per quanto mi riguarda, vale per i fraseggi di Baricco quel che valeva per tutto ciò che poteva esserci da criticare negli attivisti della flottiglia: davanti all’immane massacro compiuto da Israele a Gaza, chiunque dica o faccia qualcosa per fermarlo dice o fa una cosa giusta, e fare le pulci a lui invece che a chi commette quelle atrocità è insopportabile. Più straniante, oltre che datato, mi pare il modo in cui Baricco si mette a descrivere i magnifici risultati della rivoluzione digitale. Per capirci, arriva a dire in proposito, oggi, al tempo di Elon Musk e degli altri tecnoligarchi insediati attorno alla Casa Bianca, testualmente: «Abbiamo reso estremamente difficile creare sacche protette dove far accadere la Storia al riparo da sguardi indiscreti; e abbiamo reso più impervio l’esercizio del dominio da parte di qualsiasi élite». Sarà.
In ogni caso, non farei tanto il pignolo se questa apparente ingenuità, questa chiusura autoreferenziale in un mondo idilliaco che non esiste, non avesse qualcosa a che fare con il seguito, il passaggio a mio parere più grave. E cioè: «Sentire la parola riarmo filtrare dalle più rappresentative menti del continente è una vergogna, e a livello intellettuale un fenomeno incomprensibile. Essere costretti ad ascoltare i toni virili con cui si promette di difendere ogni singolo metro della nostra amata terra europea è inaccettabile. Piuttosto, ci sarebbe da dire con tutt’altra mitezza che difenderemo ogni singolo metro della civiltà che stiamo immaginando, e non lo faremo con le armi, ma con l’ottusa pazienza con cui l’animale cerca l’acqua e i fiumi il mare». In fondo all’articolo Baricco ha aggiunto due righe: «Se questo testo vi piace, diffondetelo. Se vi piace molto, traducetelo, prima che lo faccia l’Ia, e fatelo girare». E la prima cosa che ho pensato è stata: no, per carità. Non traducetelo mai.
Mi chiedo infatti con quali sentimenti potrebbe leggere queste righe non dico un cittadino ucraino che viva da tre anni sotto le bombe, al quale i russi abbiano rapito il figlio o i nipoti, ma anche soltanto un cittadino polacco, estone o lituano. Un cittadino di uno qualunque di quei Paesi che hanno già conosciuto la violenza dell’oppressione russa, e vedono ogni giorno a pochi chilometri dai propri confini le atrocità commesse quotidianamente in Ucraina, i bombardamenti sugli asili e sugli ospedali, le camere di tortura, gli stupri, i rapimenti. Per poi vedere droni e caccia russi violare lo spazio aereo del proprio paese, per testare la capacità di reazione della Nato e dell’Europa.
E che cosa gli diciamo noi italiani, che cosa gli dice il nostro raffinato scrittore a chi dovesse leggerlo da laggiù, ai nostri fratelli europei che confinano con la guerra, sottoposti alle continue minacce e provocazioni del regime di Putin? Diciamo loro di stare tranquilli, perché noi «difenderemo ogni singolo metro della civiltà che stiamo immaginando, e non lo faremo con le armi, ma con l’ottusa pazienza con cui l’animale cerca l’acqua e i fiumi il mare». Fossi un grande scrittore anch’io, avrei senz’altro una formidabile frase a effetto da mettere qui, in chiusura, ma non mi viene niente, e forse è meglio così.
Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi.
L'articolo Baricco e la chiusura della mente italiana davanti alla guerra proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0













































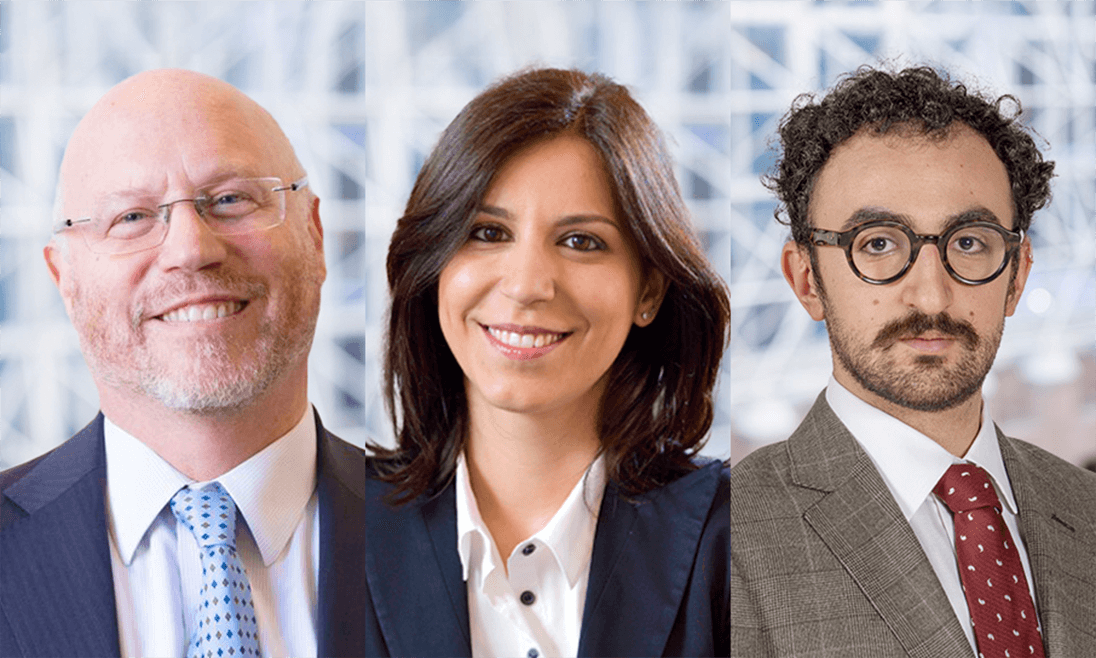


















































































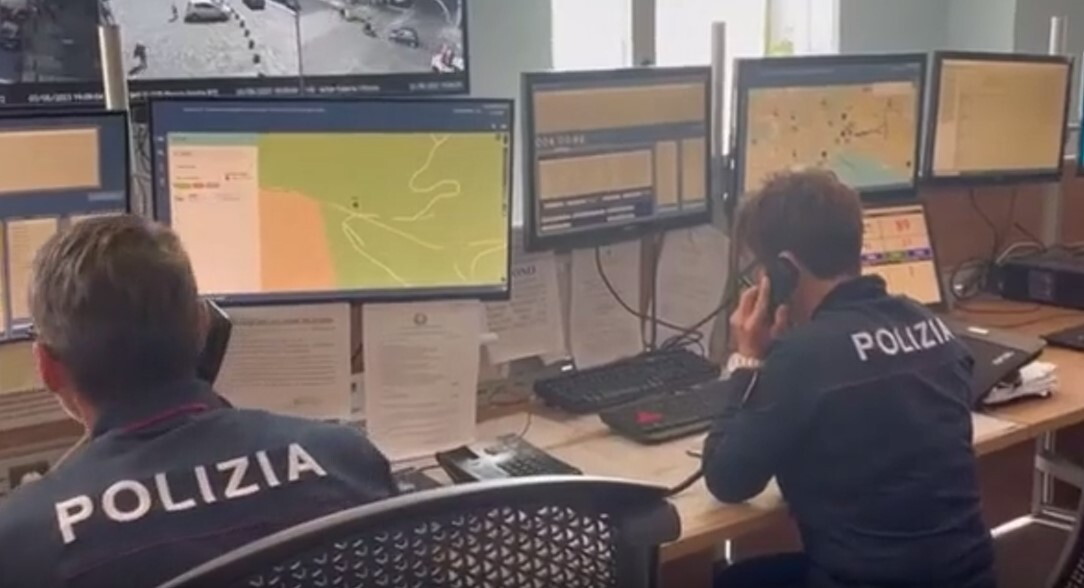
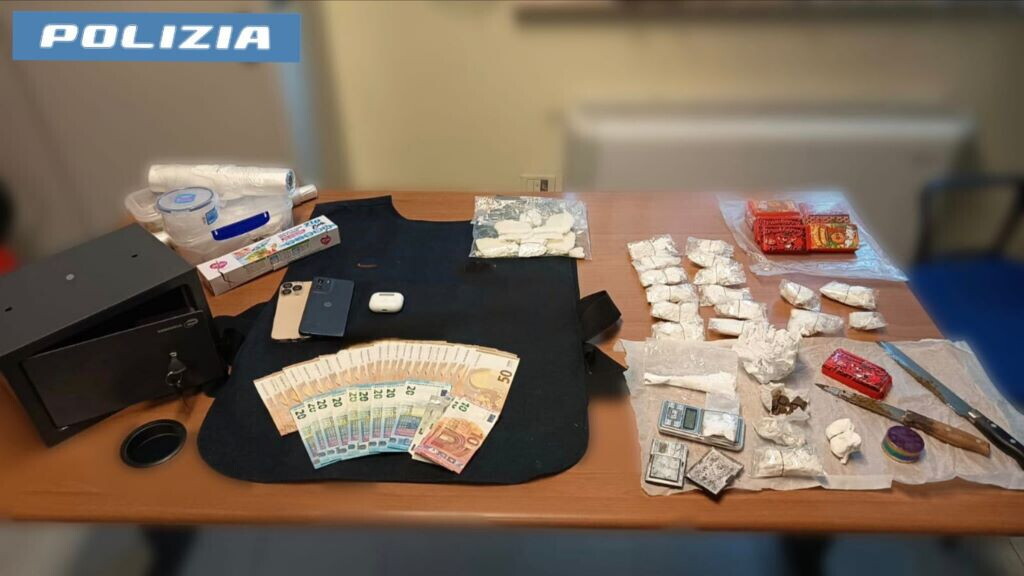
































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































