Cartelle esattoriali e notifiche: l'irreperibilità spiegata dalla Cassazione

lentepubblica.it
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 24781 del 2025, interviene su un tema cruciale per contribuenti e amministrazioni: la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento e il rapporto tra risultanze anagrafiche e accertamenti eseguiti dall’ufficiale notificatore.
La decisione contribuisce a delineare con maggiore precisione la distinzione tra le diverse forme di irreperibilità del destinatario, fornendo un’interpretazione che incide direttamente sulle modalità con cui gli atti impositivi vengono recapitati.
La vicenda esaminata dai giudici
Il caso riguardava la notifica di una cartella di pagamento avvenuta presso l’indirizzo in cui la destinataria risultava ufficialmente residente. L’ufficiale notificatore, recatosi sul posto, aveva però riscontrato che sul citofono e sulla cassetta postale non compariva alcun riferimento al nome della contribuente, e che il custode del condominio aveva dichiarato che la stessa si era trasferita altrove. Di conseguenza, l’atto era stato notificato seguendo la procedura prevista dall’articolo 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973, che disciplina i casi di irreperibilità assoluta.
La contribuente aveva impugnato la cartella, sostenendo che la notifica fosse nulla in quanto l’indirizzo utilizzato coincideva con quello indicato nei registri anagrafici. Secondo la sua tesi, l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto applicare la procedura prevista dall’articolo 140 del codice di procedura civile, relativa all’irreperibilità temporanea o “relativa”.
La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta
La Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire la differenza tra i due concetti, spesso fonte di equivoci e contenziosi. L’irreperibilità relativa si verifica quando il destinatario — o una persona autorizzata a ricevere l’atto — non si trova temporaneamente nella residenza, nel domicilio o nella dimora noti. In questo caso, la legge impone che l’atto sia depositato presso la casa comunale e che venga data comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata, come stabilito dall’articolo 140 c.p.c.
Diverso è invece il caso dell’irreperibilità assoluta, che ricorre quando il luogo in cui effettuare la notifica risulta del tutto sconosciuto, o quando si accerti che il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia. In tali circostanze, la normativa fiscale consente una procedura più snella, disciplinata appunto dall’articolo 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973, la quale non prevede l’obbligo di ulteriori comunicazioni.
Secondo la Cassazione, nel caso in esame si trattava chiaramente di irreperibilità assoluta: l’ufficiale notificatore aveva constatato che non esistevano elementi esterni — come un nome sul citofono o una cassetta postale — che potessero collegare la contribuente all’indirizzo in questione. Inoltre, la dichiarazione del custode confermava il trasferimento, rendendo dunque applicabile la procedura più semplificata prevista dal legislatore.
Il valore probatorio degli accertamenti dell’ufficiale notificatore
Uno dei punti centrali dell’ordinanza riguarda il peso probatorio delle attestazioni contenute nella relata di notifica. I giudici di legittimità hanno ribadito che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale notificatore godono di fede privilegiata, in quanto si tratta di atti pubblici redatti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, le loro dichiarazioni possono essere contestate solo attraverso una querela di falso, lo strumento processuale previsto per mettere in discussione la veridicità di un atto pubblico.
Di conseguenza, la Corte ha escluso che il certificato anagrafico, pur rilevante sotto il profilo indiziario, possa prevalere sulle risultanze dirette dell’attività dell’ufficiale. Le informazioni anagrafiche, infatti, hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate dagli accertamenti “sul campo”, che rappresentano una verifica concreta della situazione reale.
Continuità con la giurisprudenza più recente
L’ordinanza si colloca nel solco di precedenti analoghi, tra cui la pronuncia n. 27729 del 2024, in cui la Cassazione aveva già evidenziato che le certificazioni anagrafiche non possono essere considerate prova definitiva della residenza effettiva del destinatario. L’iscrizione nei registri comunali, spiegano i giudici, può non riflettere la realtà dei fatti, specialmente quando la persona si sia trasferita senza aggiornare tempestivamente la propria posizione anagrafica.
Implicazioni pratiche
Il principio sancito dalla Corte assume particolare importanza per la gestione delle notifiche degli atti tributari e giudiziari. In sostanza, la Cassazione afferma che l’attività dell’ufficiale notificatore prevale sulle risultanze anagrafiche, se da essa emerge che il destinatario non è più collegato al luogo indicato. Solo una querela di falso potrebbe ribaltare tale accertamento.
Per i contribuenti, in buona sostanza, questo significa che non è sufficiente dimostrare di essere formalmente residenti a un certo indirizzo per contestare la validità di una notifica: ciò che conta è la corrispondenza effettiva tra residenza dichiarata e luogo reale di dimora. Per l’amministrazione, invece, la pronuncia fornisce un ulteriore strumento per difendere la legittimità delle proprie notifiche, a condizione che le verifiche dell’ufficiale siano documentate in modo preciso e completo.
The post Cartelle esattoriali e notifiche: l'irreperibilità spiegata dalla Cassazione appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















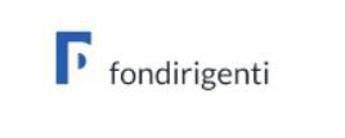




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































