Il Pnrr che doveva cambiare l’Italia sta cambiando solo chi gestisce i fondi


A meno di un anno dalla scadenza per il completamento degli obiettivi del Pnrr, fissata al 31 agosto 2026, e a poche settimane dal versamento dell’ultima tranche di dicembre, il governo Meloni ha di fronte a sé una corsa contro il tempo dopo aver speso solo un terzo delle risorse. A luglio di quest’anno ha dichiarato di aver incassato la settima rata e di aver inviato richiesta all’Unione europea per l’ottava, ma il ministro con delega al Pnrr Tommaso Foti, a margine del Festival dell’economia di Trento, ha annunciato una sesta revisione del piano in autunno: «Il livello attuale di spese sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è soddisfacente. Vogliamo ricalibrare gli obiettivi per la nona e la decima rata».
Le zavorre che rallentano l’esecuzione del piano sono quelle di sempre, aggravate dalla portata dei fondi da spendere. Scarse capacità di spesa ordinaria, riferite ai finanziamenti delle politiche di coesione, si ripresentano qui all’ennesima potenza. Bandi farraginosi che coinvolgono diversi strati istituzionali, propensione a produrre norme, circolari e Faq a dismisura, Comuni che operano in un contesto di risorse modeste con conseguente bassa attitudine all’investimento e la carenza di figure tecnico-amministrative adeguate, sono i mali cronici con cui il paese deve fare i conti. E i bandi diretti ad assumere geometri, architetti e ingegneri sono andati quasi deserti. Posizioni non appetibili per un professionista con anni di studio alle spalle, poiché precari, destinati alla singola opera da realizzare.
Fuori dall’influenza nazionale vi è l’inflazione alimentata dall’aggressione russa contro l’Ucraina, che ha innalzato indirettamente anche i costi del Pnrr. In una spirale dove l’aumento dei prezzi al consumo ha scatenato la reazione delle banche centrali; il costo dell’energia e dei beni industriali si è inevitabilmente riversato sulle capacità di spesa.
Insomma, pare che la priorità sia evitare lo sperpero di risorse. Il Governo non intende rinunciare a nessuna delle quote destinate all’Italia, in totale centonovantaquattro miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti. Così, una revisione dopo l’altra, ha spostato i propositi iniziali: si sono ridotti gli investimenti in opere pubbliche a fronte di maggiori incentivi per le imprese, spesso tramite crediti d’imposta. In breve, la collettività paga, seppur indirettamente, parte delle tasse che sarebbero in capo alle imprese. A maggio 2024 la Corte dei Conti registra tale aumento nell’ordine di undici miliardi, fermo restando che la percentuale di fondi destinati a opere pubbliche rimane maggioritaria.
Il portale Open Pnrr di Openpolis rileva un’affermazione sempre maggiore delle S.p.a. come soggetti attuatori del piano. Sovraintendono la fase progettuale e fungono da attori intermedi fra Governo e realizzazione dell’opera. Partecipano a bandi e avvisi indetti dai ministeri per ottenere i finanziamenti, per poi, a loro volta, indire gare appaltatrici. Identificare la natura di questi enti risulta semplice poiché ogni progetto è riconducibile a un solo attuatore. Le S.p.a. gestiscono la fetta più sostanziosa dei finanziamenti, pari a trentotto miliardi, per un valore medio di 1,8 milioni di euro a progetto. Un ammontare talvolta corrisposto anche in affidamento diretto, senza le lungaggini di una gara d’appalto, come per le acquisizioni di servizi e forniture.
Se la scelta risulta vantaggiosa per velocità e snellezza burocratica, non lo è per trasparenza e lotta alle infiltrazioni criminose. Giuseppe Busìa, presidente dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac), commenta: «Troppi continuano a essere gli affidamenti diretti, la cui incidenza numerica, sul totale delle acquisizioni di servizi e forniture del 2024, è risultata essere di circa il novantotto per cento. Preoccupa, soprattutto, il crescente addensamento degli affidamenti non concorrenziali tra i centotrentacinquemila e i centoquarantamila euro, a ridosso della soglia: più che triplicato rispetto al 2021, quando il valore-limite era di settantacinque mila euro. Specie in alcuni contesti, gli amministratori onesti si trovano più esposti a pressioni indebite, non potendo più opporre l’esigenza di dover almeno aprire un qualche confronto competitivo con altri operatori economici, al di sotto dei centoquarantamila euro», come riporta nella relazione annuale al Parlamento.
Un’analisi degli effetti è poi ostacolata dalla carenza di dati chiave, come il codice identificativo di gara (Cig). Contando che, nei dataset resi pubblici, sotto l’ala dello stesso bando vengono posti più progetti, l’indecifrabilità aumenta. Non mancano scivoloni plateali in stile commedia all’italiana: date di aggiudicazione risalenti agli anni Settanta, importi di un solo euro o persino superiori alle risorse stanziate per il progetto. Tolti i casi di dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione per cui ciò è da ritenersi attendibile, si parla di errori di decine di milioni di euro.
Al di là di qualsivoglia valutazione, il Pnrr ha impresso nell’agire pubblico una trasformazione nelle modalità gestionali delle risorse, con un passaggio a logiche di ispirazione privatistica. Si svuotano competenze dalle istituzioni pubbliche, per drenarle verso strutture di diritto privato come le S.p.a. Uno spostamento che è anche territoriale, poiché si facilitano inevitabilmente investimenti nelle grandi città. In termini di miliardi, rispettivamente: Roma cinque, Milano 2,7 e Napoli 2,3. Mentre solo il 39,1 per cento degli investimenti è destinato al Mezzogiorno, in una spirale delle diseguaglianze che rischia di saldare lo status quo invece di rivoluzionarlo.
I tempi stringono, il problema non è solo italiano. Il Parlamento europeo aveva esortato la Commissione a estendere di ulteriori diciotto mesi il recovery and resilience facility (Rrf), lo strumento finanziario dei vari piani nazionali di ripresa e resilienza, ma questa ha declinato. «L’attuale ritmo di attuazione non è sufficiente a garantire il conseguimento di tutti i traguardi e di tutti gli obiettivi entro agosto 2026», si legge nella nota della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 4 giugno. La reticenza si spiega con la contrazione di debiti sui mercati dei capitali in relazione alle tempistiche concordate con i paesi membri che, in caso di proroga, comporta il pagamento di interessi crescenti.
Esclusa dunque l’estensione temporale, la Commissione suggerisce di adottare strategie più pragmatiche. Definisce alternative per rendere più flessibile l’impiego dei fondi, prima fra tutte il dirottamento verso l’industria europea della difesa (Edip) o lo sviluppo di componenti del programma spaziale e di connettività dell’Unione. Insieme a queste, razionalizzare la portata degli obiettivi secondo il principio di essenzialità, definanziare le misure più indietro e ampliare quelle già avviate con forte domanda. Per citare alcuni esempi, Transizione 4.0 e il Superbonus.
Sarà possibile inoltre realizzare i progetti incompiuti tramite fondi nazionali o europei ordinari, come le grandi opere infrastrutturali. Altra opzione, trasferire fino al quattro per cento della dotazione al fondo InvestEu al fine di stimolare investimenti privati, o capitalizzare banche e istituti di promozione nazionale.
L'articolo Il Pnrr che doveva cambiare l’Italia sta cambiando solo chi gestisce i fondi proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















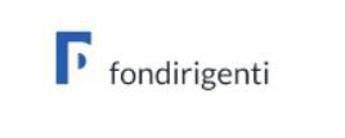




















%20Bressanone%20Turismo_Max%20Rella%20(2).jpg)
















































































































































-1749821006062.jpg--chivasso__al_via_la_manutenzione_straordinaria__lavori_su_strade_e_marciapiedi_fino_al_2_dicembre.jpg?1749821006101#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































