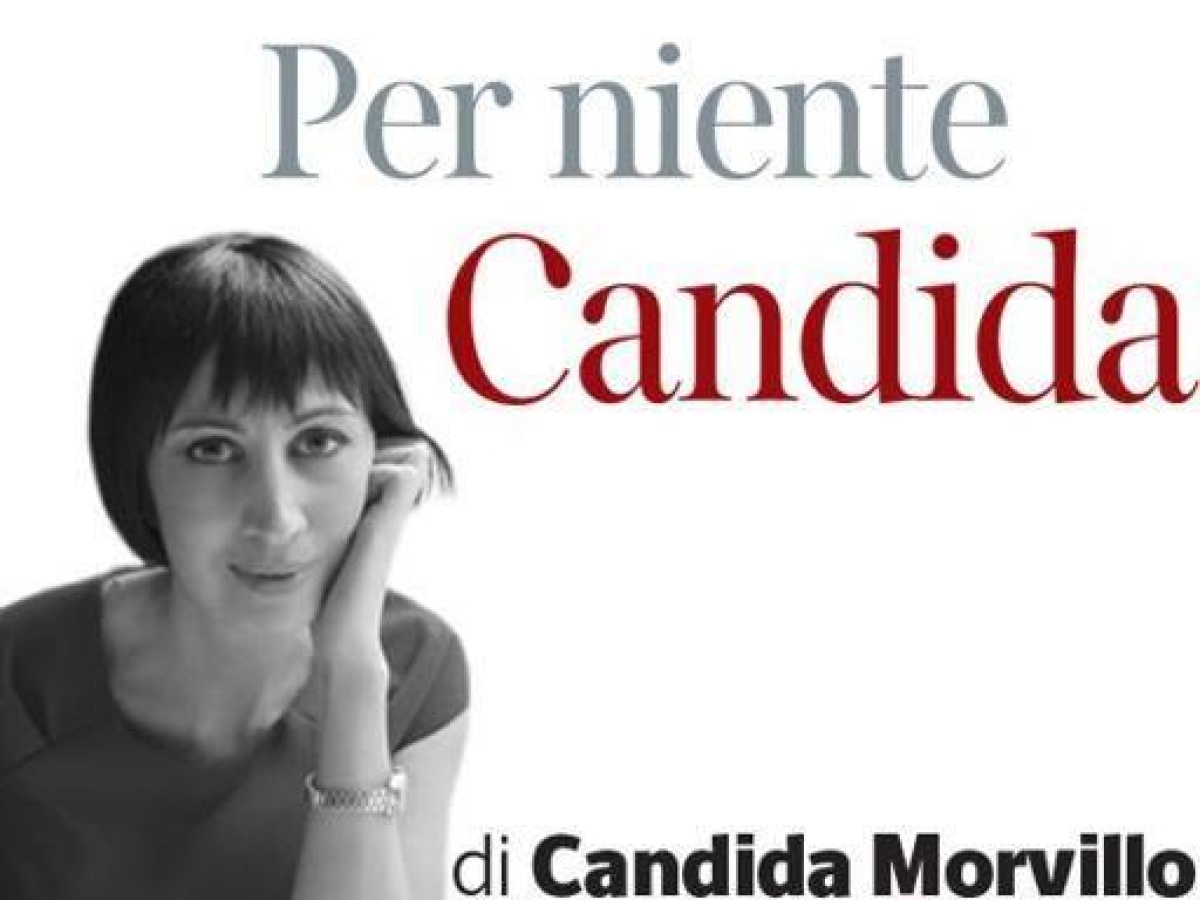Israele, Trump e la sconfitta di Hamas che smentisce la realtà virtuale dell’Occidente


Tra la pompa magna di Donald Trump in Israele, e il commovente ritorno a casa degli ultimi ostaggi vivi, il 13 ottobre è stata una giornata bellissima per gli israeliani. Umanamente e politicamente.
Il discorso di Trump alla Knesset sembrava la puntata finale di un grande tv show degli anni Novanta: l’appello con tanto di complimenti a Marco Rubio, Steve Witikoff e Jared Kushner, più tante ruffianate, come l’esposizione della figlia Ivanka convertita all’ebraismo, ma anche tanta durezza, ammorbidita da battute, come l’annuncio dell’acquisto di nuovi bombardieri.
Tanti colpi di scena, come l’appello all’unità tra Benjamin Netanyahu e il centrista Yair Lapid; insistenza che suggerisce al governo israeliano una via d’uscita, garantita dagli Stati Uniti, in caso di rottura con gli impresentabili Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, perfetti candidati capri espiatori.
Di grande effetto anche la contestazione di due parlamentari arabi (ricordiamolo sempre che i palestinesi in Israele votano e hanno dei rappresentanti in parlamento) che, interrompendo il discorso di Trump, sono stati allontanati dall’aula.
Gran colpo di scena la richiesta del presidente degli Stati Uniti al suo omologo israeliano Isaac Herzog di graziare Netanyahu in caso di condanna.
Sebbene il Premier israeliano (a causa pare delle pressioni del presidente turco Recep Erdogan) non si sia recato a Sharm el-Sheik per il summit di pace, il 13 ottobre è stato confezionato ad hoc per essere il suo trionfo.
Il rifiuto di Recep Tayyip Erdoğan non va visto tanto come un esercizio di potere, sebbene si tratti del leader che più di tutti si sta avvantaggiando dei due grandi conflitti (Ucraina e Gaza); dato che il clou del summit è stato la firma del piano di Trump da parte di Turchia, Qatar ed Egitto, la presenza del maggior beneficiario (l’odiato Netanyahu) sarebbe stato umiliante per i tre stati mediorientali, pur alleati dell’Occidente, che hanno avuto maggior responsabilità di questa guerra.
I qatarini, si sa bene, hanno ospitato e finanziato Hamas, sostenendone con il proprio conglomerato mediatico Al Jazeera tutta la narrazione. Gli egiziani, che vantano normalizzazione con Israele dal 1978, forse per un tacito accordo post golpe tra militari e la Fratellanza Musulmana (madre di Hamas), hanno tollerato o comunque non contrastato a sufficienza il contrabbando sul proprio confine con la Striscia di Gaza (sono stati trovati tunnel carrabili). Infine la Turchia ha offerto ad Hamas un’alternativa diplomatica e strategica rispetto all’asse iraniano.
Uno dei mille ingarbugliamenti nel conflitto arabo-israeliano, sin dalle sue origini, è l’evidente incapacità dei Paesi levantini di ammettere una sconfitta pur evidente, firmare una resa chiamata resa e raggiungere una pace che sia una patto invece che una affermazione del favore divino. Questo si sposa perfettamente con certi deliri ideologici occidentali che stanno incubando visioni per cui la forza è sempre peccato, la vittoria è sempre sconfitta morale e chi non si arrende è il vero vincitore perché non soccombe ai fatti. Ciò alimenta molti meccanismi della guerra mediatica, ormai cognitiva, che le società chiuse muovono contro le società aperte (anche se ormai quasi società socchiuse).
La cifra di Netanyahu nella guerra come nella vittoria (cantata troppo presto) è nettamente il cinismo: della narrazione mediatica gliene importa poco, anche di quella processuale. Il premier sotto il quale è avvenuta la belluina carneficina del 7 ottobre 2023, per salvarsi, doveva diventare il comandante che guidava Israele alla vittoria strategica.
Ebbene, nonostante tutta la narrazione sul “suicidio di Israele”, Netanyahu ha scosso il mondo dimostrando che la spada è più potente del touch screen, cioè che la potenza militare crea ancora più realtà e conseguenze fattuali rispetto alla forse troppo inflazionata realtà virtuale in cui l’Occidente vive la propria cupio dissolvi.
Agli occhi dei propal ostili al cessate il fuoco, che dimostrano sempre un grande amore per la Palestina che non c’è, ma un ben minore amore per i palestinesi che ci sono, ciò è forse più imperdonabile della mattanza di Gaza.
Basta rilevare il cambio di clima, i riposizionamenti in corso, adesso come già durante la guerra all’Iran (il lavoro sporco per conto dell’Occidente) che aveva creato una parentesi più rilassata per Israele.
Del resto la capitolazione di Hamas è arrivata nel periodo di maggior pressione per Israele (e quindi di maggior forza mediatica di Hamas che vampirizza il movimento propal), grazie solo all’occupazione di Gaza City (che aveva dimostrato ormai l’impotenza operativa dei terroristi) e all’attacco, pur fallito, in Qatar che ha definitivamente aperto i canali tanto ai consiglieri di Trump quanto alle colombe del mondo arabo.
Netanyahu ha appaltato la narrazione della guerra a Trump, lasciandogli il merito.
La responsabilità di Netanyahu e le scommesse di Sinwar
Da sempre Netanyahu ha sostenuto, almeno solo teoricamente prima del 7 ottobre, l’idea dell’applicazione della forza per sconfiggere il terrorismo. In netto contrasto con lo scetticismo della maggior parte degli analisti, convinti che la pressione bellica (sul medio e lungo termine) il terrorismo invece lo generi.
Del resto la lunga esperienza governativa di Netanyahu si era caratterizzata solo per occasionali rappresaglie e periodica “potatura” di Hamas, arrivando addirittura a concedere l’afflusso di ingenti capitali nella Striscia; non solo soldi della solidarietà internazionale ma anche finanziamenti e investimenti qatarioti che oramai stanno al centro di uno scandalo politico. Questo “pizzo” doveva in teoria sedare l’irredentismo hamasista, ma l’attacco del 7 ottobre ha fatto crollare questa colpevole illusione.
Illusione che aveva inoltre corroborato una malriposta fiducia nelle potenti tecnologie di sorveglianza, con conseguente demansionamento del Mossad sempre più escluso dalla questione palestinese.
C’è da dire che segnali di una particolare mobilitazione di Hamas, a inizio estate 2023, erano giunti alle orecchie dello Shin Bet, il servizio d’intelligence militare che si occupa dei territori palestinesi occupati. Netanyahu non prestò attenzione a queste notizie, preso invece dalle grandi proteste contro le sue riforme della giustizia (una delle diverse spaccature sociali israeliane su cui Hamas puntava per far implodere lo Stato ebraico).
La dottrina del Mossad, le cui infiltrazioni consistono in una diplomazia selettiva e sotterranea, permetteva invece una comprensione della Striscia di Gaza che il mero monitoraggio militare non potrà mai fornire.
Grazie al Mossad (ben accomodato in Libano) si sapeva infatti dei piani di Hezbollah per un attacco da Nord e addirittura dalla Cisgiordania, un’eventualità che avrebbe causato uno shock strategico persino maggiore di quello avvenuto il 7 ottobre con l’impazienza di Yahya Sinwar. Perciò tutte le attenzioni e le forze erano rivolte lì invece che su Gaza.
Sinwar guardava con terrore all’imminente normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele, nel quadro degli Accordi di Abramo. Quel piano, avviato nel primo mandato di Trump, ha accelerato il lungo processo di integrazione israeliana nel Medio Oriente certificando il passaggio dei palestinesi da problema politico a noia umanitaria. C’è da dire che l’isolamento dei palestinesi è innanzitutto dovuto al pessimo giudizio che i vicini arabi sunniti hanno tanto di Hamas quanto dell’Anp.
Mentre Hamas si legava alla Repubblica Islamica dell’Iran, potenza sciita che mira all’egemonia sul Medio Oriente sunnita, Israele si proponeva al posto e in vece degli ingombranti statunitensi come principale deterrente contro le mire degli ayatollah, conquistando così un posto nel cuore delle monarchie del golfo e validandosi come realtà meiorientale invece che elemento estraneo occidentale.
L’Anp, con a capo il vecchissimo Abu Mazen, da tantissimi anni non ha più grande credibilità tra gli stessi palestinesi. Sta in piedi in Cisgiordania solo grazie all’occupazione israeliana che impedisce ad Hamas di spazzarli via come han fatto a Gaza nel 2007. Per questo motivo emiratini, sauditi, giordani ed egiziani non hanno avuto nel recente passato grande voglia di investire su di essa, che rimane comunque un’istituzione riconosciuta dall’Onu e che siede nella Lega Araba.
Il 7 ottobre, Sinwar ha umiliato la capacità militare israeliana per riacquistare valore politico o almeno far perdere punti a Israele. I palazzi arabi però non hanno dato credito alla barbarie di Hamas, che per altro aveva scatenato i suoi alleati dell’Asse della Resistenza: Hezbollah che paralizzava il Libano, gli assurdi Houthi che minacciavano i sauditi all’ingresso del Mar Rosso dallo Yemen straziato e le milizie che infestavano l’Iraq.
Il Piano B di Sinwar era dunque l’appello alle piazze arabe per forzare i loro governanti. Non è andata bene neanche questa. Sebbene esista ancora un forte sentimento di solidarietà araba verso i palestinesi, unito a un non trascurabile antisemitismo, la giovane società civile mediorientale è abbastanza in sintonia con le classi dirigenti a proposito del processo di normalizzazione con Israele.
I paradigmi della guerra di Gaza
I primi cinquanta giorni hanno dato sin da subito l’idea di quel che sarebbe stato l’intero conflitto: l’inesorabile martellare di Israele, il viva la muerte di Hamas, la priorità data da Netanyahu alla tenuta del suo governo piuttosto che alla tenuta della società e della catena di comando israeliane, l’ipocrisia dei vicini arabi, la tensione nel regime iraniano tra minacce e autotutela, l’imbarazzo statunitense in campagna elettorale, una pressione umanitaria impolitica come unica prospettiva unitaria europea, la tregua concessa solo e soltanto con il rilascio di ostaggi.
Tutto ciò con il ruolo, sempre più unilateralmente ostile, degli apparati delle Nazioni Unite contro Israele. Da subito questi hanno facilitato il gioco di Hamas nel trasformare il diritto internazionale, i corridoi umanitari e persino la diplomazia in campi operativi bellici alla pari dello spazio fisico. Con Hamas invisibile tanto fisicamente sotto la Striscia quanto metaforicamente all’ombra delle diplomazie. Mentre Israele aveva il proprio settentrione paralizzato dall’offensiva di Hezbollah (con decine di migliaia di sfollati), si è aperto in maniera virulenta il fronte mediatico (ancora aperto) fomentato dalle evidenze della devastazione e della tragedia nella Striscia. Ciò sotto l’impulso di un’informazione duopolizzata tra Al Jazeera e la stampa hamasiana che si avvale di un vastissimo ed eterogeneo sistema di new media, moltiplicato dagli utili influncer propal.
Affrontando la Striscia di Gaza, Israele si è trovata davanti una novità ancora senza nome. Attraverso l’esasperazione della tattica dello scudo umano, Hamas ha creato il più grande scudo umano della Storia, che è allo stesso tempo una giungla del Vietnam e una trappola diplomatica e reputazionale.
Più ancora della Corea del Nord, la Striscia di Gaza rappresentava il più radicale esperimento distopico mai concepito: un’arma biologica tecnologicamente primitiva ma comunque sofisticatissima; in cui il prefisso bio designa non un batterio, ma la vita stessa di una comunità trasformata in dispositivo.
L’urbanistica bellica di Hamas, che sistematizza le infrastrutture militari (gli oltre cinquecento chilometri di tunnel) con quelle civili, ha preparato un bivio tragico per il buon senso d’Israele (strappare i rovi mentre i rovi strappano te o bruciare il roveto con i suoi abitanti?), ma anche una narrazione irresistibile per il senso comune occidentale (l’inversione di Davide e Golia, il paradosso tendenzioso della questione ebraica, la parodia dell’Olocausto, la nuda vita che si ribella al tecnosovrano…).
Lawfare
Questa sfida, subdolamente ideata da Hamas per eludere il diritto internazionale e addirittura portarlo al parossismo, costringe Israele a rischiare continuamente di commettere crimini pur impiegando metodi legittimi su obiettivi legittimi.
All’ombra (o alla luce?) di normalizzazione dell’eccezionalità, espansioni interpretative, errori di valutazione, degradazione del principio di distinzione e via cantando si è aperto il fronte giuridico di questo conflitto.
Il procuratore Khan della Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per le leadership di Hamas e del governo israeliano. Come per Putin, oggetto di simile provvedimento, il mandato di arresto limita fortemente la credibilità e l’agibilità politica del governo israeliano.
Pur non essendo riconosciuta da Israele e Stati Uniti, la Corte Penale pretende giustamente (sebbene con diverse ombre procedurali e personalistiche) di poter entrare nel merito di crimini di guerra e crimini contro l’umanità ai danni dei palestinesi. I capi d’accusa hanno ricevuto una serie di contestazioni che, al di là dei dettagli tecnici, provano a squalificare il processo come indebita e pericolosa forma di pressione diplomatica.
Parallelamente la Corte internazionale di Giustizia, su iniziativa del Sud Africa, ha aperto una valutazione sul conflitto in corso come possibile genocidio. La corte non si è affatto espressa sul merito delle accuse, ma ha fornito semplicemente una serie di misure preventive.
A ciò si è da poco aggiunta una Commissione dell’Onu, sulla cui composizione sorvoliamo per il momento, che ha prodotto un rapporto sul presunto genocidio che risulta giuridicamente e metodologicamente fragile.
Come spiegato dalla giurista Elena Marchetti, la guerra a a Gaza non dimostra il dolus specialis – l’intento specifico di distruggere un gruppo in quanto tale – richiesto per configurare il crimine di genocidio, confondendo la retorica di guerra con la volontà di sterminio.
Le dichiarazioni di funzionari israeliani, spesso tradotte o selezionate in modo arbitrario, vengono usate come “prove” sia dell’intento genocidario sia dell’incitamento al genocidio, in un ragionamento circolare e incoerente. Ma, come stabilito dalla giurisprudenza internazionale da Norimberga al Rwanda, il linguaggio politico o militare, anche se duro o disumanizzante, non costituisce di per sé prova dell’intento genocidario.
Ignorando il contesto del 7 ottobre e non considerando spiegazioni alternative plausibili, la Commissione dell’Onu ha fallito il test probatorio richiesto: le sue conclusioni non reggono a un esame giuridico serio e finiscono per far crollare la stessa accusa che intende sostenere.
Obiettivi raggiunti e serendipità
Il gabinetto di guerra israeliano aveva stabilito tre obiettivi all’inizio dei combattimenti: la liberazione degli ostaggi, lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e infine il disarmo e la rimozione di Hamas dal governo della Striscia di Gaza.
Molti analisti, come se si trattasse di stabilire un punteggio a Risiko, provano a valutare l’esito del conflitto sulla base di quell’elenco di cui, attualmente, è stato raggiunto solamente la liberazione degli ostaggi.
Per quanto Hamas abbia sottoscritto formalmente il proprio disarmo per lasciar spazio a un’amministrazione tecnocratica di transizione, le dichiarazioni di molti suoi esponenti non fanno sperare bene.
C’è però da dire che Hamas, se non fosse stato per la vergognosa ed esiziale distrazione del 7 ottobre, non è la principale minaccia per Israele. Questa guerra, che ha comunque annichilito e costretto alla resa Hamas, ha ottenuto degli obiettivi molto più strategici per il presente e per il futuro dello Stato ebraico.
Innanzitutto la vittoria su Hezbollah, la principale minaccia militare ai confini di Israele. Un’operazione che ha stupito il mondo tanto per la chirurgica capacità militare quanto per la formidabile intelligence (i cercapersona esplosivi, che hanno tanto sconvolto il clero sciita da far dare la colpa alla magia nera salomonica).
Il Libano adesso ha una possibilità di riscatto istituzionale, nel nuovo quadro di rapporti regionali. Hezbollah deve ancora essere disarmato, ma l’unità tra sunniti e cristiani nella direzione degli Accordi di Abramo fa sperare bene.
Anche la maleducatissima pressione israeliana sulle truppe Unifil è stata una scommessa tanto ideologica quanto pragmatica di Nethanyahu: il vecchio modello di interposizione delle Nazioni Unite a trazione europea diventa facilmente uno schermo per il terrorismo e un limite per le democrazie.
La sconfitta di Hezbollah ha immediatamente portato alla fine del regime di Assad in Siria. L’azione lì è stata pilotata da Erdoğan, a quanto pare con l’aiuto dei servizi ucraini che hanno potuto così infliggere un colpo strategico alla Russia che in Siria teneva navi e interessi importanti, oltre che il derivato prestigio.
Il nuovo governo siriano è abominevole, per quanto messo in giacca e cravatta dai turchi: ha dimostrato di aver mantenuto molto del jihadismo da cui proviene. Essendo però al guinzaglio della Turchia, Paese Nato, sicuramente risulta un notevole progresso rispetto alla Repubblica Islamica. Pur essendo passato da significativo partner commerciale di Israele a diretto avversario, Erdoğan vuole portare la Siria nei Patti di Abramo. Se i suoi toni antisraeliani sono solo una manovra consensuale (in Turchia il tema è molto sentito), le sue tattiche antisraeliane sono invece molto decise e sincere. Volendo spingersi il più possibile verso Suez sta cercando di contendere all’Iran il cuore di Hamas, per ripulire e manovrare anche loro; affermando così dai Dardanelli la volontà di diventare re dei choke point mediterranei: ricordiamo la sua presenza in Libia e gli interessi in Algeria per bypassare il Marocco via Sahara Occidentale.
Sull’Iran c’è poco da dire. Per quanto uranio arricchito possa ancora tenersi in tasca, la Repubblica Islamica esce mortificata dal fallimento di Hamas, dalla sconfitta di Hezbollah, dall’insignificanza degli Houthi (che attirano sempre più l’insofferenza del resto mondo), dalla penetrabilità dei propri apparati e soprattutto dalla manifesta debolezza militare.
Infine, nonostante le numerose profezie su imminenti guerre civili tra sefarditi e ashkenaziti, tra coloni illegali e arabi israeliani, tra ultraortodossi ed esercito o tra opposizioni e maggioranza, il tessuto sociale israeliano sembra ancora il più saldo del Medio Oriente.
L'articolo Israele, Trump e la sconfitta di Hamas che smentisce la realtà virtuale dell’Occidente proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0










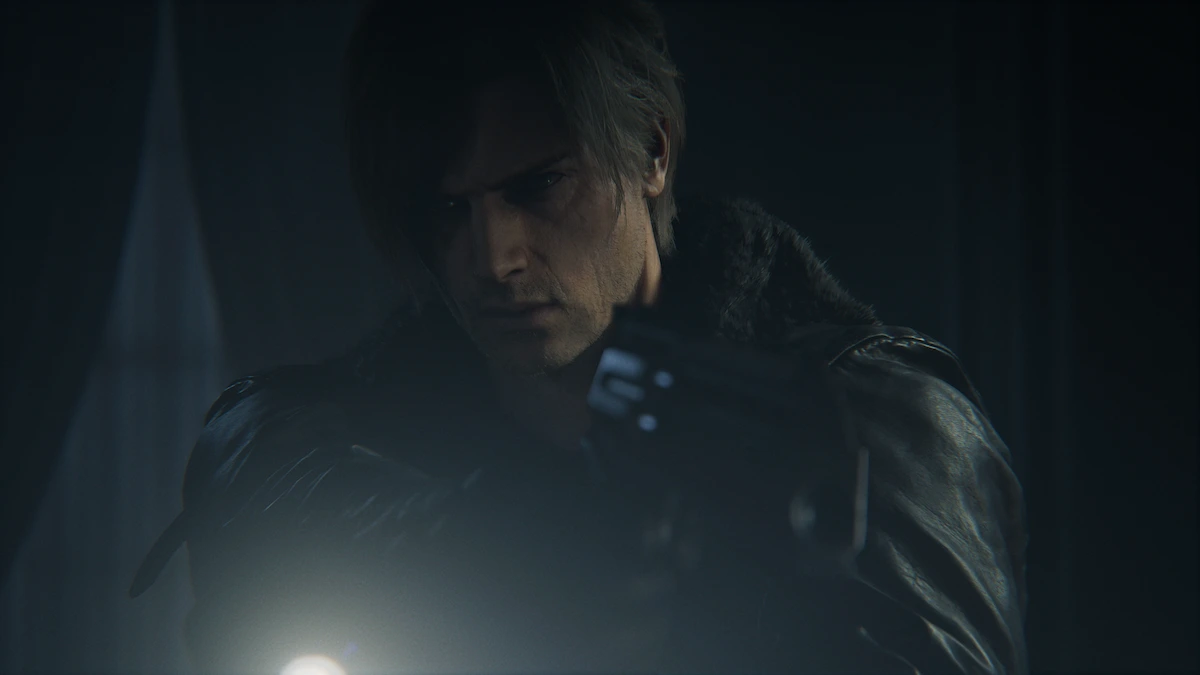





















![Mondiale WRC 2026. Nel bene e nel male sarà stagione cruciale. Allora, vogliamo essere seri? [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48295138/1200x/si202510171702.jpg)






























 Fonderie Ariotti S.p.a.-U88165282343aAr-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)



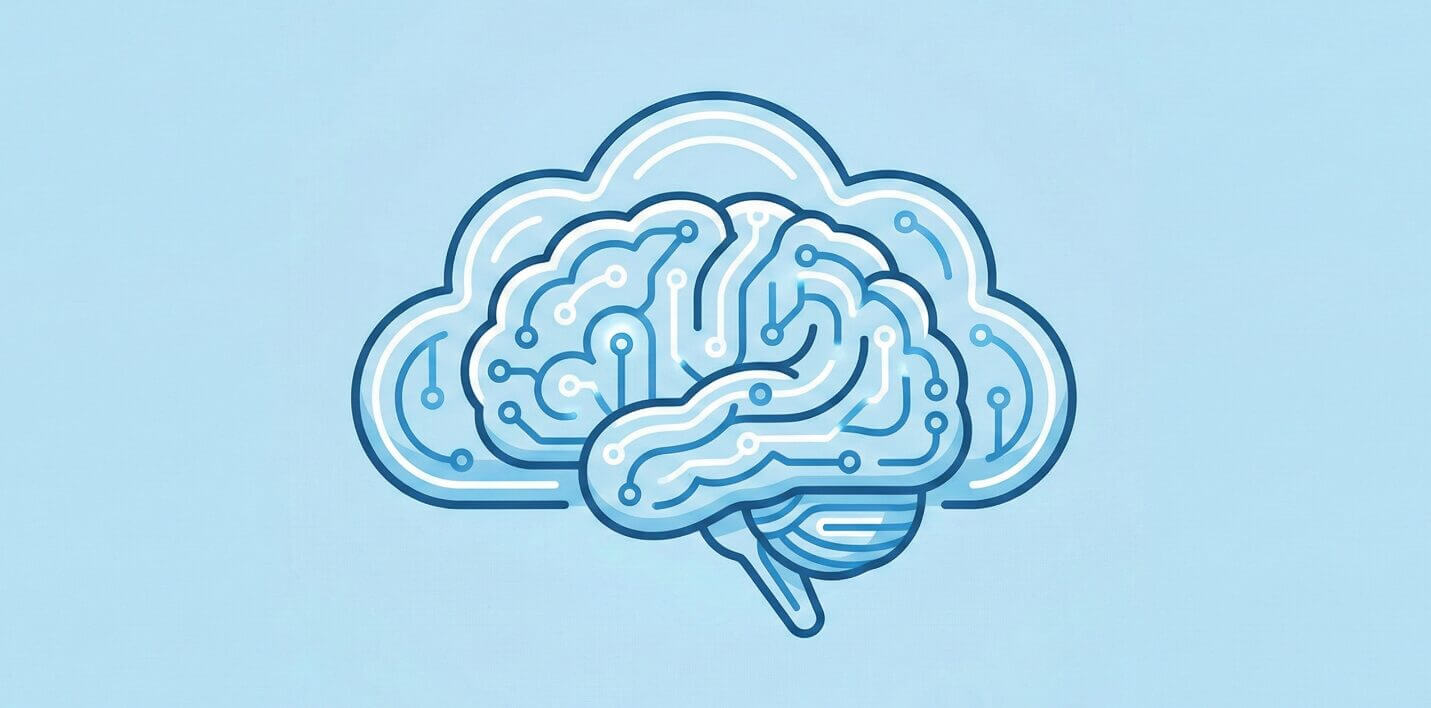











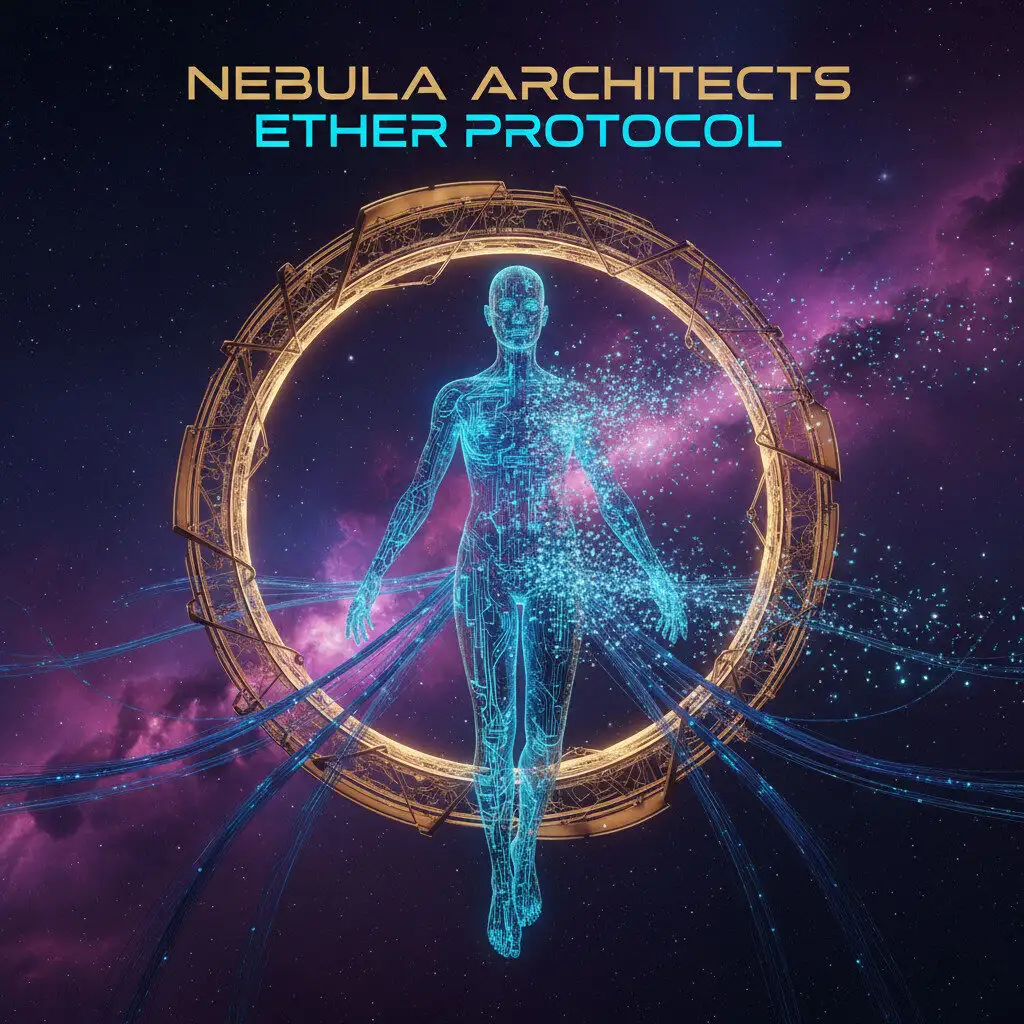



/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/offerte-attuale-coinbase-incredibile-approfittane-subito.jpg)























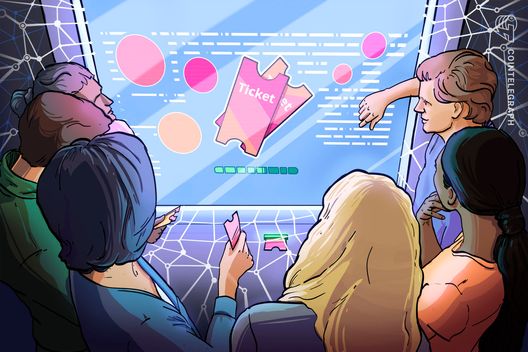






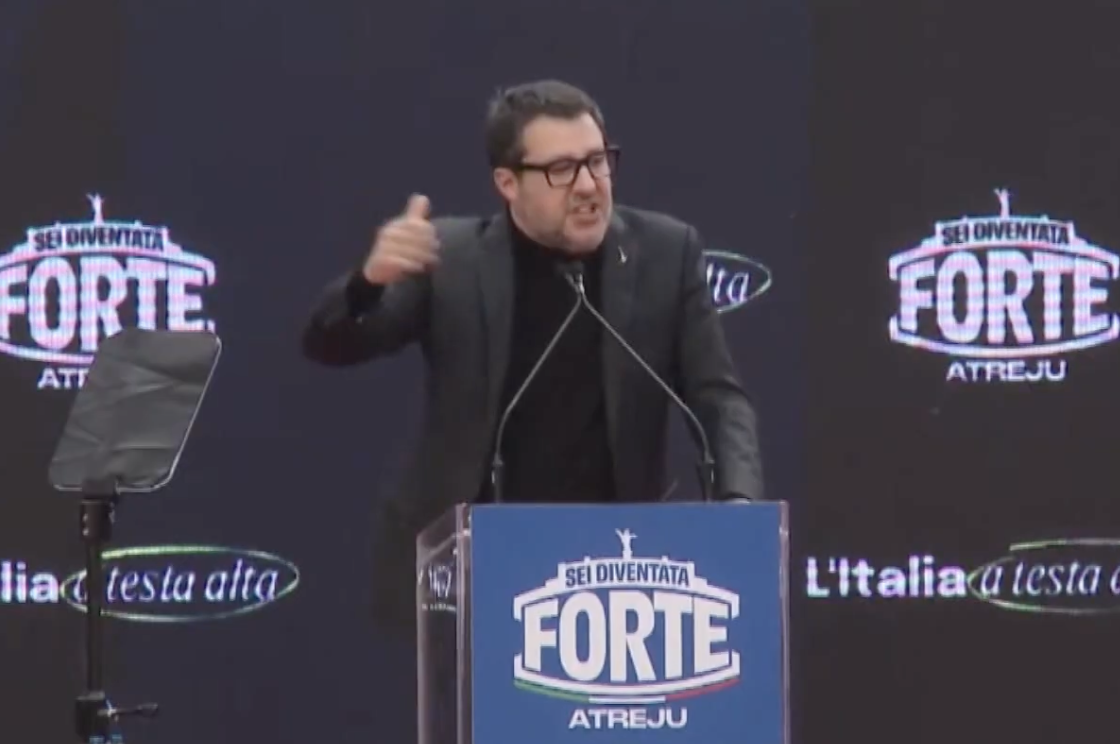












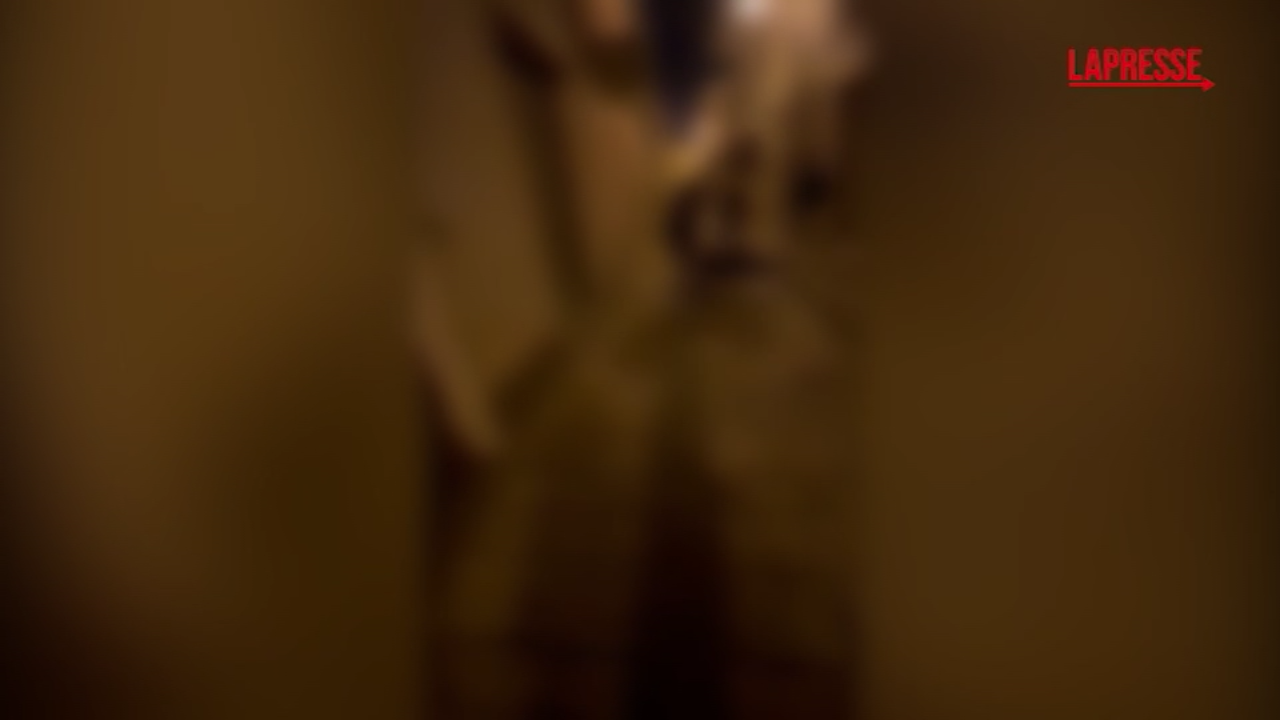































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)