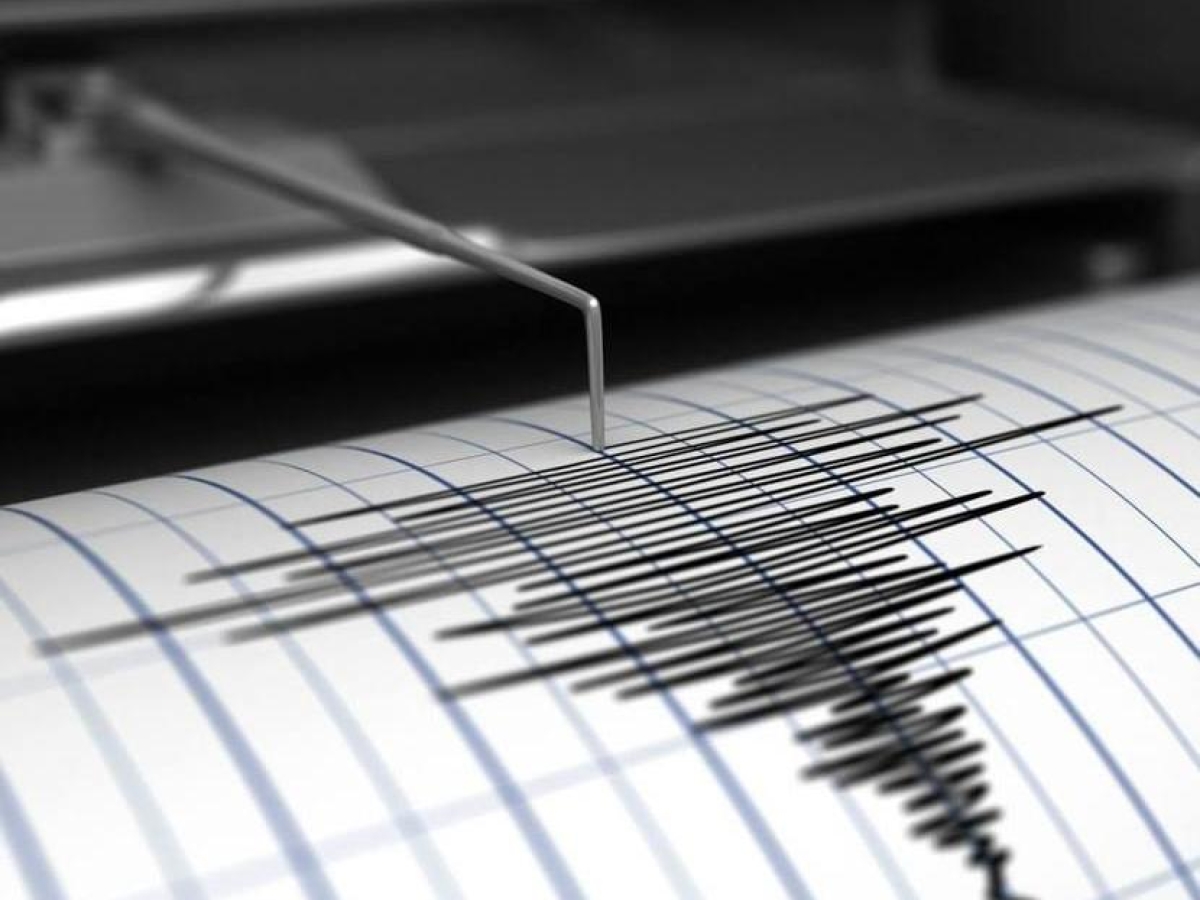La tragedia dei nuovi critici che non leggono, non guardano, non studiano


Al duecentesimo, ma forse duemillesimo, articolo sul fatto che non sappiamo più niente, non studiamo più, siamo una società talmente ignorante che i nostri nonni con la quinta elementare erano meno ciucci di noi, a questo punto bisogna che io mi scusi con Sara. Ma, prima di arrivare a Sara, devo passare da Marc Maron.
Marc Maron è un comico americano scarsissimo di cui una volta non avremmo saputo il nome ma che, nell’epoca della scarsezza istituzionalizzata, è diventato non solo ricco e famoso ma pure rilevante: come ha spiegato bene Fran Lebowitz, con un pubblico di merda non puoi che avere artisti scarsi, perché non c’è una platea esigente che li costringa a essere all’altezza.
Ovviamente Marc Maron ha un podcast, anzi ce l’aveva: l’altroieri è andata in onda l’ultima puntata. Il suo podcast si intitolava “WTF”, che sta per «what the fuck», ovvero «ma cosa cazzo»: Marc appartiene alla genia dei sessantenni che si sentono trasgressivi a dire le parolacce, scommetto che si fa pure le canne, wow, non ti diranno mai boomer.
Dieci anni fa Barack Obama, che ha un vero talento per capire come gira la moda, andò a registrare una puntata nel garage di Maron. Quindi, per l’ultima puntata, l’altroieri Maron è andato da lui. È una conversazione piena di spunti interessanti, tra cui la definizione di «vittoria parziale» (di più semplice comprensione per il medio ascoltatore di podcast rispetto a «riformismo») come tipo di obiettivo del quale i giovani di sinistra devono imparare ad accontentarsi invece di dire «o tutto o niente» (la puntata è stata registrata prima degli accordi in medioriente, ma «vittoria parziale» è un’eccellente risposta a quelli per cui questa pace non va bene perché non è la pace perfetta).
Per tenere fede alla mia natura di guardatrice di dita e non di lune, tuttavia, io vorrei concentrarmi sul momento in cui Marc e Barack parlano di podcast. Di come sia difficile non essere fraintesi causa frammentazione: uno guarda mezza frase sui social, e non sa in che contesto hai detto cosa.
Maron dice che lui tutela i suoi ospiti da questa decontestualizzazione pubblicando la puntata solo in audio, senza video la gente ti spezzetta meno, e a me viene da piangere. Non stiamo parlando di portare Proust alla maturità avendo letto il Bignami: stiamo parlando delle fiabe della buonanotte. Neanche quelle siete più in grado di ascoltare per intero. Il futuro è luminoso.
Shea Serrano è un texano quarantaquattrenne che né io né voi abbiamo mai sentito nominare. Serrano scrive, come tutti, ha un Substack, come tutti, pubblica libri, come tutti. Nella bulimia da letture su Diane Keaton degli ultimi giorni, mi è comparsa davanti l’anticipazione d’un libro di Serrano che il New York Magazine pubblicò sei anni fa.
Il libro s’intitola “Movies (and other things)”, Amazon dice che è stato tra i più venduti nella classifica del New York Times, che è quel che si scrive nell’editoria americana quando si vuole dare un certo peso al fatto che un libro abbia venduto: gli americani sono così fessi che, se gli stessi dati di vendita che hanno tutti glieli impacchetti come dotati del bollino del giornale autorevole, ne sono più colpiti.
Naturalmente «New York Times bestseller» non vuol dire niente: un conto è essere alto in classifica per un anno e mezzo come “La generazione ansiosa”, un conto è affacciarsi in classifica la settimana dell’uscita, rito di passaggio che non si nega a nessuno. Però il libro di Serrano può essere sia andato davvero bene, per due ragioni che attengono a ciò su cui ho già scritto due milioni di articoli.
È un libro coi disegnetti, cioè l’unico genere che non spaventa i non lettori di questo secolo in cui persino un podcast intero è troppo impegnativo. Ed è un libro molto personale, sui film ai quali Serrano pensa dovrebbe andare un Oscar ideale per la commedia romantica e altre amenità. Credo d’aver già raccontato di quella volta che un direttore disse alla me ventenne che quel che avevo scritto era pieno di «io», e «io» solo se sei Giorgio Bocca. Era il Novecento, quando pur di non dire «io» gli intervistatori facevano dei giri di parole da mal di testa (c’è ancora qualcuno che scrive «noi» come parlasse a nome del giornale: fanno tenerezzissima).
Poi è arrivato questo secolo, in cui «io» ha smesso d’essere il più lurido di tutti i pronomi (devo aggiungere «cit.» o avete le basi?), ed è diventato la formula lasciapassare. Tempo fa, mentre commentavamo un pezzo di costume orrendo scritto da una che fino a prima dell’espansione di «io» non scriveva «io» neanche se scriveva una recensione, chi l’aveva pubblicato sospirò che «ormai c’è questo fraintendimento che tutto ciò che è personale sia interessante». Quanta verità.
Comunque. L’anticipazione del NYMag era un capitolo in cui Serrano parlava di “Tutto può succedere”, introdotto dalle righe in cui Serrano diceva che questa, e non “Io e Annie”, era la sua preferita tra le interpretazioni di Keaton. C’era poi una nota che vi vado a parzialmente ricopiare. «Questo in verità è il primo film in cui ho visto Keaton, che è in parte la ragione per cui ci sono così affezionato».
“Tutto può succedere” esce a Natale del 2003. Serrano ha 22 anni. È un americano che di lavoro scrive di cinema ed è arrivato a ventidue anni senza aver visto “Il padrino”? Non dico “Interiors”. Non dico “Baby boom”. “Il padrino”. Non mi tengo, e come una vera Vongola75 gliene chiedo conferma su Twitter, o come si chiama ora. Non so cosa spero, forse che mi dica che è cresciuto in una grotta senza elettricità e ha visto il suo primo film a 22 anni e poi da lì ha recuperato, fino a 21 aveva solo letto tutti i libri esistenti.
Serrano conosce i suoi polli, e quindi cita il mio tweet dicendo che non l’ha visto fin dopo l’università, “Il padrino”, e si assicura una sleppa di risposte simpatizzanti: il pubblico che non sa un cazzo vuole applaudire solo gente che non sa altrettanto un cazzo. Che problemi potrà mai avere un secolo in cui pretendiamo intellettuali che non ne sappiano più di noi altrimenti ci complessiamo?
«Normalizziamo il vedere per la prima volta i film a qualunque età», commenta qualcuno, e io mi chiedo se esista un verbo più imbecille di «normalizzare» (forse quel suo sinonimo sciatto che è «sdoganare»): cosa devi normalizzare, è già normale non sapere un cazzo, guardatevi, siete gente che rivendica di non aver visto i classici fin dopo i quarant’anni, siete la nuova normalità e mi fate venir voglia di buttarmi dalla finestra.
Il 2010 è l’anno della mia vita adulta in cui ho fatto più vita mondana, non dico che uscissi con la frequenza di quando avevo vent’anni ma quasi. E molte sere di quell’anno le ho passate a prendere per il culo Sara, una poracrista che era nel giro di gente che frequentavo in quel periodo.
Sara aveva qualche anno più di me, e quindi quando disse che lei non aveva mai visto né “Il padrino” né “Via col vento” trasecolai, e non lasciai più trascorrere una serata senza che quell’argomento fosse affrontato: come ha fatto una bambina del Novecento a non vedere “Via col vento”, che quand’eravamo alle elementari davano su Rai1 una volta l’anno tutti gli anni? Cosa facevi di sera quand’avevi sette anni: andavi in disco?
Ecco, vorrei scusarmi con Sara, che fino a ieri credevo fosse l’adulta più ignorante da me mai incontrata. Perché ieri sono andata sul Substack di Shea Serrano, in cui, per gli abbonati paganti, l’intellettuale più rappresentativo di questo tempo sbandato parla di film. Ho letto gli stralci gratuiti che erano lì, non più avvincenti di voci Wikipedia.
Ero lì che leggevo i suoi penzierini su “Titanic”, che a un certo punto, subito prima del confine in cui per continuare a leggere devi abbonarti, diventavano personali, proprio come li vuole il pubblico pagante. Ed eccola lì, la considerazione personale di Serrano. «Rose portava con sé, a bordo della nave, alcuni dipinti. Due dei quali, apprendiamo, sono di Picasso. È un po’ imbarazzante, ma fino a qualche mese fa io pensavo che Picasso fosse contemporaneo di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Pensavo fosse uno di quegli artisti del Cinquecento. Ma no: è morto nel 1973!».
Vorrei scusarmi con Sara non solo perché ha un’infarinatura di Novecento sufficiente a saper collocare Picasso nel tempo, o un’infarinatura di parametri estetici sufficiente a non pensare che Guernica possa essere un dipinto rinascimentale. Vorrei scusarmi con Sara soprattutto perché Google dice che, prima che decidessimo che le mansioni di critico culturale erano alla portata proprio di chiunque, Serrano lavorava, dopo la laurea, come insegnante in una scuola media.
Abbiamo voluto la democrazia, e la scolarizzazione, e la seconda rivoluzione industriale, ed è finita così. Che ogni ciuccio che una volta avrebbe raccolto pomodori ora ha un PhD, col quale nel migliore dei casi diventerà un intellettuale pubblico e nel peggiore insegnerà ai vostri figli, il tutto con le stesse competenze culturali con cui avrebbe raccolto pomodori. Poi i vostri figli diventeranno adulti, e troveranno intellettualmente stremante ascoltare un podcast.
La buona notizia è che, se quegli stessi figli guardano “Il padrino” prima dei trent’anni e “Titanic” prima dei quaranta, loro è il regno, loro la potenza, e loro le mansioni di critici culturali coi libri in classifica. Il futuro è luminoso.
L'articolo La tragedia dei nuovi critici che non leggono, non guardano, non studiano proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0



































.jpg)




















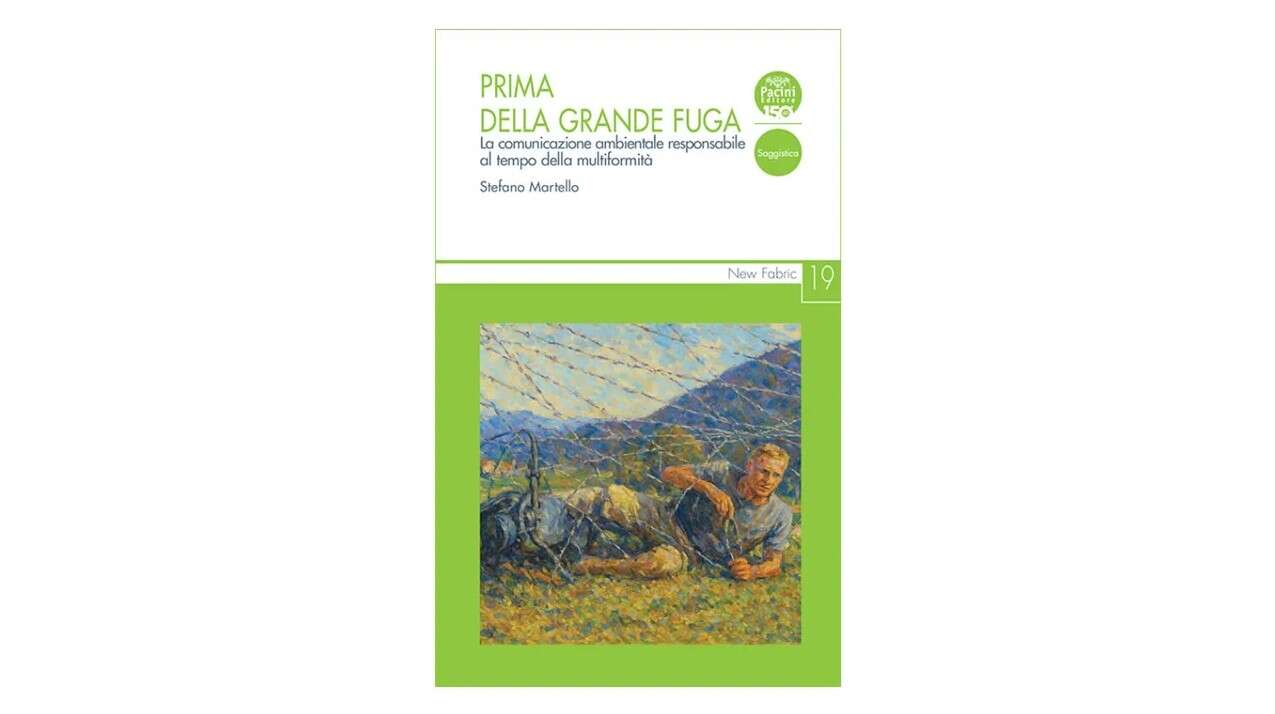










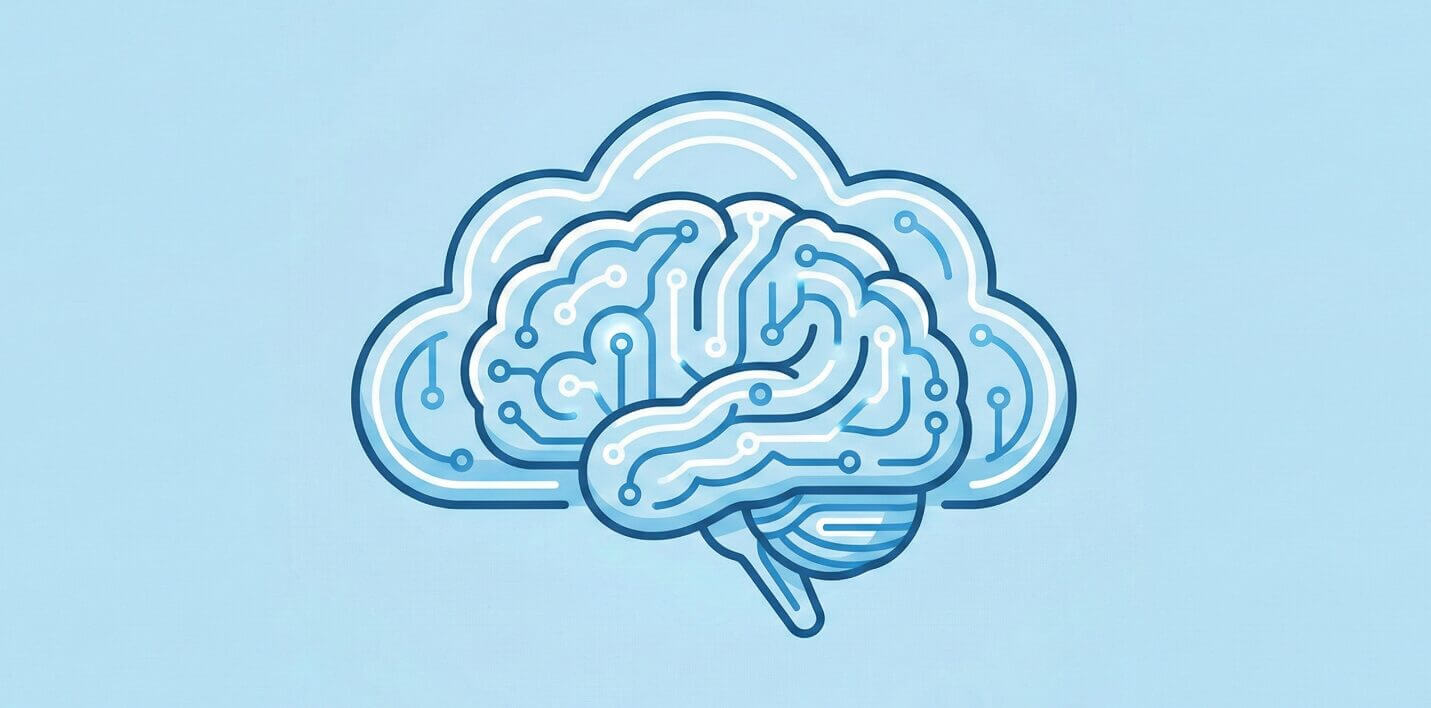















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/donna-utilizza-computer.jpg)

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/per-natale-fatti-regalare-50-euro-in-bitcoin-da-coinbase.jpg)





















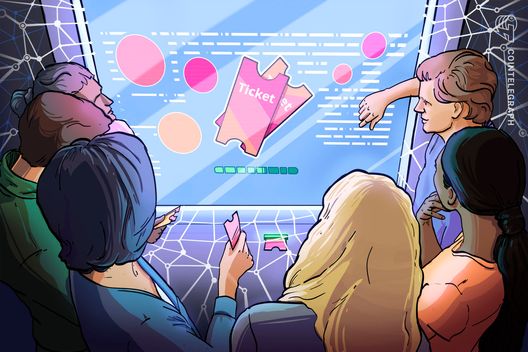
























































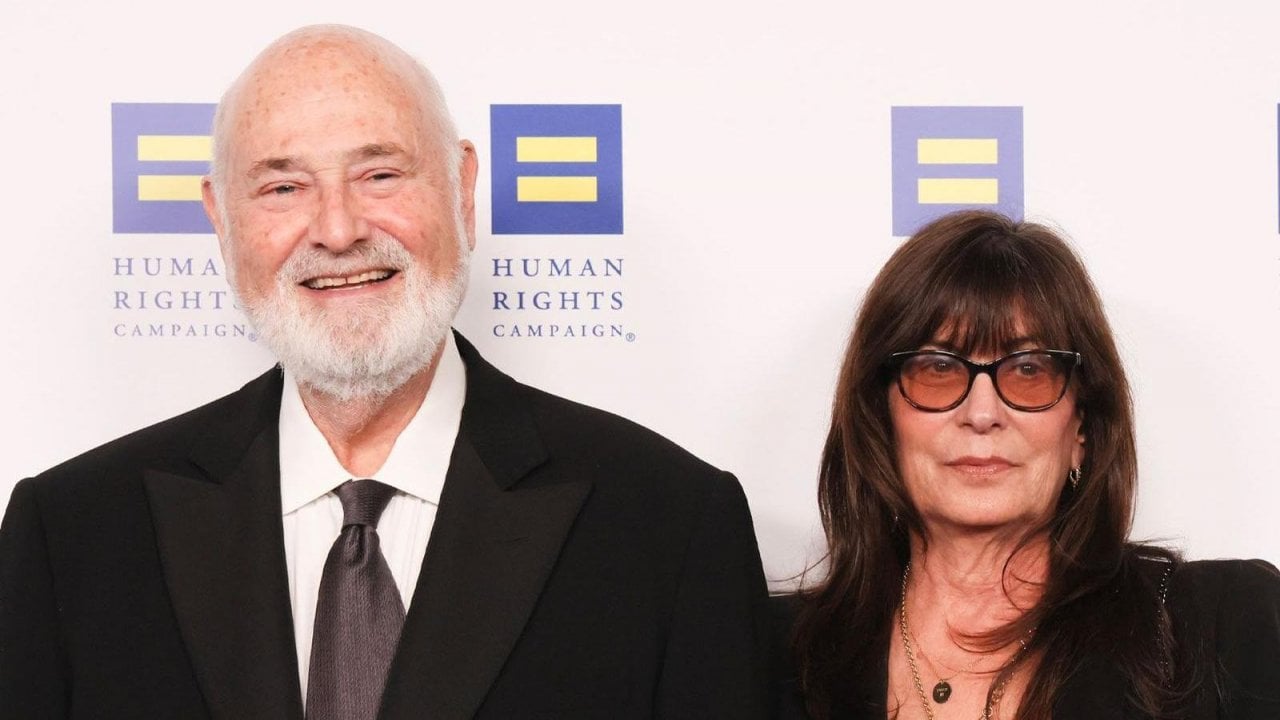

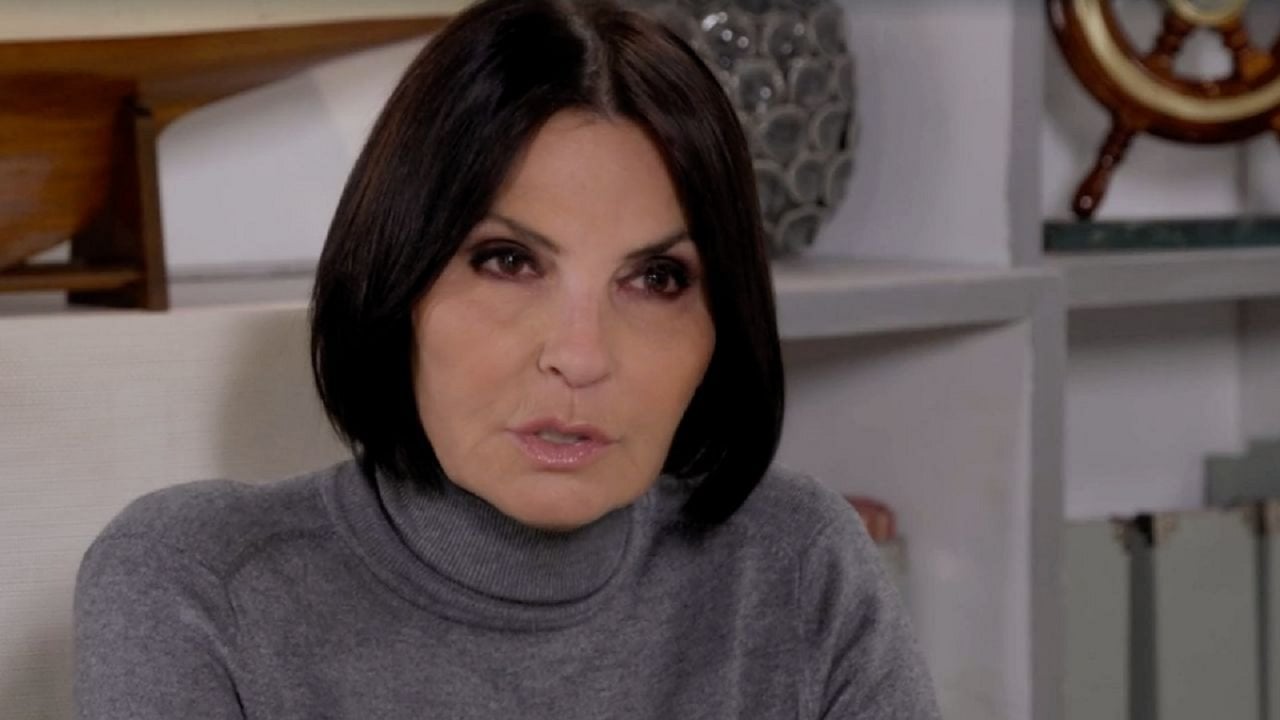
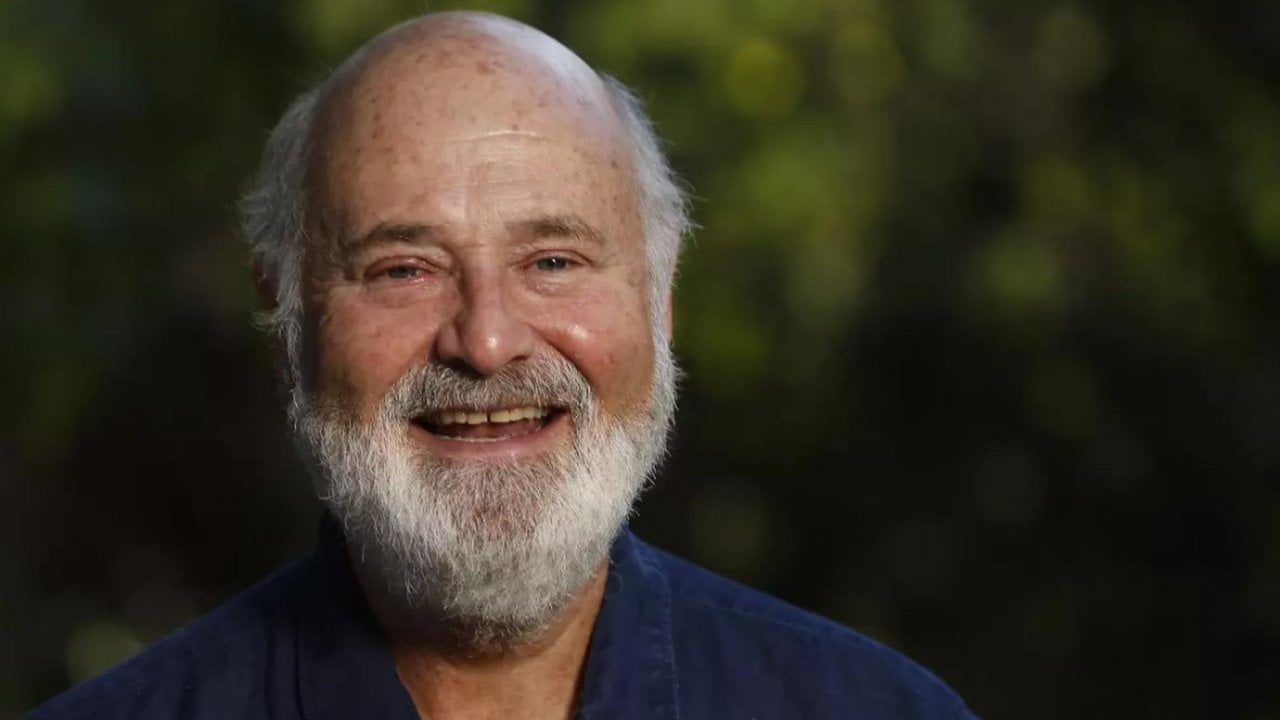



























-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)